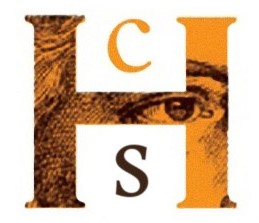Torna indietro
Le ricerche filosofiche
Ritornando alla filosofia dopo diverse esperienze, Wittgenstein si rende conto di avere fallito il suo principale obiettivo: fondare la relazione tra linguaggio e realtà attraverso l'identità di struttura mostrata dalla forma logica. Le pratiche linguistiche ordinarie, quotidiane, come anche i problemi tradizionali della metafisica, le prescrizioni morali e le credenze religiose possedono una loro validità; lo scopo della filosofia diventa proprio quello di cercare il senso di una qualsiaisi proposizione all'interno del contesto di un'ha prodotta. Nelle Ricerche filosofiche Wittgenstein abbandona la concezione vero-funzionale come unica teoria onnicomprensiva del linguaggio: il problema di fondo diventa la relazione tra i diversi tipi di linguaggio e il mondo. La svolta nel pensiero di Wittgenstein è segnata anche da un approccio pluralistico al linguaggio.
I giochi linguistici
Il linguaggio non possiede un senso soltanto nella misura in cui può esibire una forma logica: il suo senso coincide con l'uso che se ne fa all'interno di una certa pratica, di una cultura o una tradizione. Questo mondo dentro cui una qualsivoglia proposizione viene prodotta è una "forma di vita", e la nostra pratica comunicativa diventa un "gioco linguistico" (Wittgenstein conia una metafora tra le più fortunate e ricorrenti della filosofia contemporanea). I giochi linguistici sono estremamente diversi tra di loro per struttura, regole e funzioni; la filosofia deve allora rinunciare a trovare una forma logica comune e necessaria, per cercare piuttosto connessioni e differenze tra le varie pratiche, così come si fa quando si cercano le "somiglianze di famiglia" tra persone imparentate.
La critica al concetto e il nuovo compito della filosofia
Wittgenstein mette in discussione la pretesa della filosofia occidentale di scovrire un'essenza a fondamento della realtà e, soprattutto, attacca l'idea stessa di concetto, inteso come lo strumento fondamentale della tradizione filosofico-scientifica. Dal momento che non è possibile indicare una struttura generale del linguaggio, il filosofo deve limitarsi a descrivere i giochi linguistici, cogliendone per ognuno la specificità e le forme che lo hanno determinato.
Linguaggio privato e certezza
Se il senso di una proposizione è dato dal suo uso secondo regole condivise all'interno di un gioco linguistico, ne segue che è esclusa la possibilità di un linguaggio privato, dal momento che gli stati interiori di una persona non sono condivisibili. Andando oltre la teoria del linguaggio come raffigurazione della realtà, il concetto di certezza passa come l'asserto che diamo a quello che consideriamo vero. Wittgenstein sostiene infatti che le certezze più evidenti vanno intese come accordi raggiunti in base per ottenere conoscenze ulteriori.
Lezioni sulle Ricerche filosofiche di Wittgenstein
1. Un’immagine del linguaggio: il modello agostiniano
Le Ricerche filosofiche di Wittgenstein si aprono con una citazione di Agostino che, nelle Confessioni, ci propone nella forma di un racconto in prima persona la genesi del linguaggio nella mente di un bambino. Da una parte vi sono gli adulti (“maiores homines”) che parlano e agiscono, dall’altra vi è il bambino che osserva attentamente e che cerca di imprimere nella memoria il nesso tra il suono che sente pronunciare e l’oggetto che essi intendono e che diviene manifesto in virtù dell’immediata chiarezza dei gesti e dei comportamenti di chi parla.
Poi, all’esercizio attento del silenzio seguono i primi gesti linguistici: il bambino impara a piegare la bocca ai suoni degli altri e l’infanzia scompare, ed essa è il ricordo di quel primo apprendimento. Il bambino ora parla ed entra a far parte del «procelloso consorzio degli uomini» — il suo attento e silenzioso osservare il comportamento dei “maiores homines” gli ha infine indicato la via per far parte di una nuova comunità, per non sentirsi più straniero rispetto ai suoi stessi genitori. Così, appunto, devono essere andate le cose, — almeno secondo Agostino.
Si tratta evidentemente di un racconto e non di un fatto di cui la memoria possa farsi garante, e già questo è un punto su cui siamo chiamati a riflettere: anche se ciò che Agostino dice sembra plausibile, non si tratta tuttavia di un’evidenza empirica ma solo di un racconto che abbiamo sentito molte volte e che, proprio per questo, ad ogni nuova narrazione ci è sembrato insieme più familiare e più vero. Ora, ciò che un racconto può rendere di volta in volta più persuasivo non è un fatto, ma è solo la sua possibilità. I racconti mitici dell’origine hanno proprio questa funzione: ci immaginiamo come debbano essere andate le cose in un passato che non tollera di essere ulteriormente precisato e la favola che ripetiamo diviene il luogo in cui si disegna un’immagine della realtà, un modello che ce ne svela i tratti essenziali. Ciò che era in principio diviene ciò che in linea di principio è, e questa piega immaginativa che si lega al discorso sull’origine si fa avanti anche in questa antica favola sull’apprendimento linguistico che ci propone un’immagine del linguaggio di cui ci siamo nel tempo convinti e che costituisce lo sfondo intuitivo di una molteplicità di teorie filosofiche e di ragionamenti sulla natura del linguaggio. I nostri pensieri sono spesso fatti così: sorgono sullo sfondo di un’ipotesi, di un’immagine che deriva da una possibile spiegazione di un fatto. Vogliamo prepararci il terreno per riflettere sul linguaggio e raccontiamo per questo una favola che ci invita a compiere rapidamente il passo dal “così debbono essere andate le cose” ad una prima delineazione intuitiva dell’essenza del fenomeno che ci sta a cuore.
Ora, quale sia l’immagine del linguaggio che Agostino ci invita a condividere è presto detto:
In queste parole troviamo, così mi sembra, una determinata immagine della natura del linguaggio umano. E precisamente questa: le parole del linguaggio denominano oggetti — le proposizioni sono connessioni di tali denominazioni. — In quest’immagine del linguaggio troviamo la radice dell’idea: ogni parola ha un significato. Questo significato è associato alla parola. È l’oggetto per il quale la parola sta (Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1967, § 1).
La discussione di quest’intreccio di tesi ci occuperà a lungo, poiché costituisce il filo conduttore di buona parte delle Ricerche filosofiche, e tuttavia è opportuno fin da principio raccogliere qualche considerazione sul modello di linguaggio che Wittgenstein coglie nelle pagine di Agostino. Quest’immagine si articola in due punti: le parole denominano oggetti; le proposizioni sono connessioni di tali denominazioni.
1) Soffermiamoci innanzitutto sul primo punto. Le parole sono innanzitutto nomi che stanno per un oggetto e il bambino le impara perché vede gli adulti indicarle e insieme pronunciare un suono particolare. «Quando gli adulti nominavano qualche oggetto e, pronunciando quella voce, facevano un gesto verso qualcosa, li osservavo e ritenevo che la cosa si chiamasse con il nome che proferivano quando volevano indicarla» — Agostino si esprime così, e in questo modo di raccontare le cose è implicito che da una parte vi siano gli oggetti e dall’altra vi siano le voci che divengono significanti quando il bambino coglie nei gesti dei genitori una definizione ostensiva che trasforma quel suono in un nome della cosa.
L'origine del linguaggio per il bambino è tutta qui: in un gesto che gli permette di pensare ad una cosa quando sente una voce, e di creare così le antenne che permettono al nome di denominare l’oggetto per cui sta. E ciò è quanto dire: il gesto crea un ponte che ci permette di accordare in modo univoco il nome alla cosa, — un ponte che ci permette di pensare nel segno il designato. L’ostensione diviene così il mezzo che permette alle parole di toccare gli oggetti del mondo e che ci consente di attribuire al segno un significato e di raccordare alla forma dell’oggetto inteso la grammatica del significato che lo intende.
Che cosa significhi quest’ultima considerazione è presto detto: un suono e il violino che lo genera sono due oggetti che hanno una forma molto diversa che determina quale sia lo spazio delle loro possibili occorrenze: di due note che ascoltiamo si può chiedere quale sia più acuta e quale più grave, ma non avrebbe senso domandare quale sia più pesante — il peso è una proprietà che spetta alle cose come il violino, ma che non può essere attribuita ai suoni. Ora, quando ostendiamo un oggetto non abbiamo certo una conoscenza compiuta di tutte le sue proprietà, ma dobbiamo comunque averne già colto la forma: nella definizione ostensiva il nome acquista così, insieme al suo riferimento all’oggetto, una forma che circoscrive lo spazio delle sue occorrenze dotate di senso.
2) Siamo ricondotti così al secondo punto cui abbiamo dianzi fatto cenno: le proposizioni constano di nomi e hanno un senso proprio perché ci dicono come stanno le cose, mostrandoci in quale relazione stiano i nomi che le denominano. Le proposizioni sono immagini che raffigurano uno stato di cose, e i nomi sono i punti in cui l’immagine tocca la realtà, divenendo così applicabile ad essa. Nella proposizioni i nomi stanno tra loro in una certa relazione ed è sufficiente accostare i nomi agli oggetti perché si asserisca qualcosa: non appena i nomi toccano gli oggetti, la proposizione dice che le cose stanno tra loro proprio così, come la proposizione mostra. E diremo che sono vere quelle proposizioni che ci dicono che le cose stanno proprio come stanno, false quelle che propongono una relazione tra i nomi che non ha invece luogo tra le cose denominate.
Non vi è dubbio che queste brevi considerazioni potrebbero essere ulteriormente arricchite e che l'immagine agostiniana del linguaggio da cui abbiamo preso le mosse potrebbe essere trasformata in una teorizzazione effettiva se solo ci liberassimo dal velo delle citazioni e lasciassimo parlare il testo cui Wittgenstein pensa quando scrive queste prime osservazioni: il Tractatus logico-philosophicus. Ma non è questa la via che le Ricerche filosofiche si propongono; tutt'altro: Wittgenstein non ci invita a cercare di costruire una teoria che dia consistenza a quest'immagine, ma ci chiede invece di saggiarne con calma la percorribilità. Agostino ha troppa fretta.
Di una differenza tra tipi di parole Agostino non parla. Chi descrive in questo modo l'apprendimento del linguaggio pensa, credo, anzitutto a sostantivi come "tavolo", "sedia", "pane", e ai nomi di persona, e solo in un secondo tempo ai nomi di certe attività e proprietà; e pensa ai rimanenti tipi di parole come a qualcosa che si aggiungerà (ivi).
Per Agostino, l'origine ci mostra che l'essenza del linguaggio è nell'atto del nominare, ed anche se nelle nostre lingue non ci sono soltanto nomi, dobbiamo aver fiducia nel fatto che prima o poi le cose si aggiusteranno: il filosofo troverà il modo per riscoprire il modo e la sua relazione significante anche dietro alle forme grammaticali più complesse. Se è così che dobbiamo avere un tempo appreso il linguaggio, è così che dovrà essere la sua forma — anche se non tutto sembra sin da principio accordarsi con l'immagine che ci domina.
Da quest'immagine dobbiamo liberarci — almeno per Wittgenstein, e ciò significa in primo luogo rendersi conto che l'immagine che domina le pagine agostiniane è frutto di una conclusione affrettata e insieme della certezza che vi sia davvero una forma del linguaggio, una sua essenza che si dispiega nel nome e nel suo connettersi ad altri nomi nell'unità proposizionale.
Ma le cose forse non stanno così, e per insinuare nel lettore il dubbio che sia falsa l'immagine che Agostino si rende così persuasiva Wittgenstein lo costringe ad immaginare un diverso esempio. Dobbiamo liberarci da un modo di pensare e per farlo non possiamo semplicemente proporre argomenti, ma dobbiamo anche mostrare che è possibile orientare diversamente le nostre riflessioni. Ci serve innanzitutto un nuovo punto di avvio e per farlo siamo invitati ad immergersi nelle pieghe di un nuovo racconto:
Pensa ora a quest'impiego del linguaggio: mando uno a far la spesa. Gli do un biglietto su cui stanno i segni: "cinque mele rosse". Quello porta il biglietto al fruttivendolo; questi apre il cassetto su cui c'è il segno "mele"; quindi cerca in una tabella la parola "rosso" e trova, in corrispondenza ad essa, un campione di colore; poi recita la successione dei numeri cardinali — supponiamo che li sappia a memoria — fino alla parola "cinque" e a ogni numero tira fuori dal cassetto tante mele che ha il colore del campione. — Così, o pressappoco così, si opera con le parole (ivi, § 1).
Di primo acchito, non è facile comprendere che cosa si debba fare di questa strana storiella. Ma alcune differenze balzano agli occhi.
La prima differenza concerne la natura della relazione che ci viene proposta. Agostino ci invita ad immaginare un racconto per rispondere ad una domanda empirica: ci chiediamo come di fatto abbiamo imparato a parlare ed immaginiamo una spiegazione di questo lontano evento in conformità con un'immagine del linguaggio che è a sua volta corroborata dalla concretezza del racconto che ci viene proposto e dai suoi porosi come un ricordo che ci è solo fattualmente notato. La scena su cui Wittgenstein richiama la nostra attenzione non ha queste pretese: non chiede di essere letta come narrazione di un evento reale e non intende spiegare nulla, ma ci mostra un possibile uso del linguaggio, sia pure di un linguaggio semplicissimo che non va al di là di poche parole, colte tuttavia nella loro funzione comunicativa. Così, ad un'immagine che assume la forma incerta di un mito delle origini, Wittgenstein contrappone una finzione che ci consente di vedere il linguaggio all'opera: ciò che viene narrato assume dunque la forma di un esperimento mentale che mette alla prova la grammatica dei nostri concetti, descrivendo le forme della loro applicazione.
1. Il linguaggio e il problema della completezza
Come abbiamo visto, le prime pagine delle Ricerche filosofiche (i §§ 1–17) sono innanzitutto volte a prospettare la praticabilità di una concezione filosofica generale che potremmo riassumere così: la sfera generale della sensatezza non ci riconduce ad un cielo di oggetti platonici, né al territorio malcerto dei vissuti soggettivi, poiché il senso si dispiega sul terreno di una prassi socialmente codificata e sorretta da regole. Si tratta, appunto, di una tesi filosofica generale, e tuttavia abbiamo già visto come, se si assume questo punto di vista, sia necessario ripensare radicalmente la nozione di linguaggio: nella norma il linguaggio non è uno strumento per dare un nome alle cose; classificare gli oggetti può essere talvolta importante, ma non è che una tra le diverse funzioni del linguaggio, e ciò è quanto dire che il nome non è che una delle forme linguistiche.
Quest’ordine di considerazioni deve guidarci anche nella lettura del secondo gruppo di osservazioni che vanno, grosso modo, dai § 18 ai § 25 e che ci permettono di dare una risposta alle osservazioni che avevamo avanzato discutendo dell’analogia wittgensteiniana tra gioco e linguaggio. I giochi, avevamo osservato, sono definiti dalle regole che sorreggono il comportamento ludico e non ha quindi alcun senso parlare di un gioco incompleto: un gioco non ha lacune poiché è metro a se stesso e definisce insieme alle sue possibili mosse anche lo spazio che le rende appunto possibile. Ma ciò è quanto dire che se una mossa non appartiene in linea di principio al gioco e ai suoi possibili sviluppi non è nemmeno una sua possibile mossa e non appartiene allo spazio che il gioco intorno a sé circoscrive. O se preferite: un gioco, una volta che sia stato arricchito con nuove regole, non è più completo di quanto prima non fosse: è semplicemente un gioco nuovo. Anche per il linguaggio le cose sembrano stare così, ed è un fatto che se rileggiamo ora il § 2, ci accorgiamo che del gioco primitivo del chiedere e del portare una lastra Wittgenstein ci parla come di un linguaggio completo.
come di un linguaggio completo. E la ragione che potrebbe essere addotta per convincercene è fin troppo semplice: proprio come un gioco, anche un linguaggio (un “gioco linguistico”) circoscrive lo spazio entro cui si danno le forme sensate della prassi e ciò è quanto dire che, una volta che ci poniamo all’interno di una lingua determinata, non ha semplicemente senso parlare di una mossa che si trovi al di là del sistema che le regole codificano.
Che dire di questa presa di posizione così netta? In un certo senso si deve dire, io credo, che è semplicemente vera: proprio come le regole del gioco definiscono quali mosse gli appartengono, così la grammatica del linguaggio circoscrive la sfera della sensatezza ed è quindi evidente che nulla di sensato può rimanere al di fuori dei suoi confini e porsi come un segno della sua incompletezza. Del resto, se giudicassimo incompleto il gioco linguistico (2) dovremmo considerare tali anche ogni altro linguaggio compreso il nostro, poiché anche per le nostre lingue si può tentare un’analoga imposizione. Il tema dell’autonomia della grammatica ci costringe così a riconoscere l’insensatezza di chi pretende di sostenere che i giochi linguistici primitivi non sono soltanto semplici, ma incompleti:
Non lasciarti confondere dal fatto che i linguaggi (2) e (8) consistono esclusivamente di ordini. Se vuoi dire per questo che non sono completi, chiediti se sia completo il nostro linguaggio; se lo fosse prima che venissero incorporati in esso il simbolismo della chimica e la notazione del calcolo infinitesimale; questi, infatti sono, per così dire, i sobborghi del nostro linguaggio. (E quante case o strade ci vogliono perché una città cominci ad essere città?) (ivi).
Tutto questo è appunto vero, ma io credo, tuttavia, che il fascino per una conclusione che deriva necessariamente dalla tesi della «autonomia della grammatica» e che non si lascia intimorire dalla paradossalità della conclusione cui giunge, si leghi la consapevolezza del fatto che le regole del linguaggio stringono con la vita e con l’esperienza degli uomini una relazione più complessa di quanto di primo acchito si colga, muovendo dall’analogia con il gioco che, sotto questo riguardo, tende a rendere troppo facile la mossa che si intende compiere.
Certo, anche i giochi stringono un rapporto con la vita e sono determinati nelle loro regole dal contesto in cui occorrono. Una scacchiera ha
caselle, ma non potrebbe averne 212 perché non riusciremmo più a giocare — vi sono limiti nella nostra capacità di tenere a mente le posizioni reali e possibili dei pezzi sulla scacchiera. E ancora: qualsiasi gioco con la palla dà per scontata la costanza delle leggi fisiche e le regole del gioco si costruiscono all’interno di un contesto che deve essere senz’altro presupposto. Dopo che l’abbiamo lanciata in alto, la palla ricadrà perché così si comportano le cose pesanti, e la pallavolo può dare per scontato questo comportamento che, se venisse meno, trascinerebbe con sé la possibilità e la sensatezza stessa del gioco. Tutto questo vale anche quando abbiamo a che fare con i nostri giochi che appartengono comunque al nostro mondo e alla nostra vita, e del resto non c’è rendersi conto che il gioco varia con il variare delle culture, dei luoghi e delle attitudini degli uomini?
Tuttavia, non è difficile riconoscere che nel caso del linguaggio quest’intreccio è ancor più evidente e la constatazione dell’autonomia della grammatica deve necessariamente legarsi al riconoscimento che le regole grammaticali non operano nel nulla, ma presuppongono un contesto e si innestano nella nostra vita e nelle certezze che la dominano.
Quest’ordine di considerazioni traspare anche nell’immagine così bella e suggestiva che chiude l’osservazione da cui abbiamo preso le mosse e in un’immagine che ci invita a pensare al nostro linguaggio come ad una vecchia città in cui le case si sono strette le une alle altre in un intrico di vie che infine si apre quando il cuore della città vecchia si perde nelle strade meno frequentate della periferia:
Il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città: un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi (ivi, § 18)
Il linguaggio come una città con un centro storico e un’ordinata periferia: che cosa ci invita a pensare quest’immagine?
Ci invita innanzitutto a prendere atto della storicità del linguaggio, e a prenderne atto anche per ciò che concerne la dimensione esteriore: le forme grammaticali non sono forme fisse e definite, ma si piegano a diverse funzioni ed acquistano nel tempo una loro necessaria equivocità. Come i viottoli del centro, anche le grammatiche delle lingue si fanno in certi luoghi contorte e il loro essere state costantemente abitate le ha rese
spesso intricate e complesse, perché diversi sono gli usi che di volta in volta si è ritenuto opportuno farne.
Pensiamo per esempio al sistema dei casi linguistici. In latino l'accusativo esprime innanzitutto il complemento oggetto, ma poi anche il moto a luogo — e ciò ci sembra ancora facilmente comprensibile; la meta è, in fin dei conti, l'oggetto del nostro tendere. Ma se sfogliamo ancora la sintassi di casi, il nostro stupore di inesperti cresce, poiché la strada dell'analogia diviene davvero un viottolo dal percorso tortuoso: in latino vi è anche un accusativo di estensione per esprimere la distanza da un punto ad un altro, e vi è un accusativo per esprimere quello che su certe vecchie grammatiche si chiamava il complemento di età. E all'intrico del centro fa eco il dipanarsi geometrico delle periferie: allontanandosi dal cuore di una lingua, le forme del linguaggio si fanno più aperte e possono arricchirsi di sempre nuovi strumenti che, proprio perché vengono usati di rado, salvaguardano meglio la loro linearità. Perdendosi nelle sue periferie il linguaggio si approssima ad un calcolo, le sue regole si fanno più esatte e sembrano pagare meno lo scotto della dipendenza dal contesto entro cui sono di fatto introdotte
Ma l'immagine della città suggerisce una seconda riflessione che ci invita a cogliere sotto una diversa luce le considerazioni che abbiamo dianzi proposto. Certo, tu non puoi dire che la grammatica di un linguaggio sia incompleta perché non è in linea di principio possibile scoprire qualcosa che sia una mossa del nostro gioco e che insieme non appartenga allo spazio circoscritto dalle sue regole. Ma la via che qui ci invita a seguire è un'altra. Wittgenstein ci chiede infatti quale sia il criterio di cui ci avvaliamo per parlare di incompletezza nel caso dei linguaggi primitivi, per mostrare poi che un simile criterio non lo abbiamo. Una casa da sola non è una città, ma quante case o strade ci vogliano perché il sommarsi di edificio ad edificio formi una città — una domanda cui sembra davvero impossibile rispondere se non ci si vuole imbattere nelle pieghe dell'argomento del sorite.
Non possiamo rispondere con esattezza, questo è chiaro; e tuttavia parliamo egualmente di città di paesi, di villaggi o di poche case, applicando con sicurezza una regola che non sa scandirsi in un criterio esatto ma che è comunque percorribile. Anche se non sappiamo esattamente dire
quando un insieme di case diviene una paese o una città, abbiamo comunque un'idea della forma complessiva che ci consente di parlare di città e di paesi e non soltanto di qualche abitazione più o meno vicina ad altre. Non a tutte le domande si può rispondere allo stesso modo. Puoi rispondere con un numero se ti chiedono quante arance mancano per averne una dozzina, ma non puoi chiedere quante case manchino perché nasca un paese: ma questo non significa che non vi sia un qualche criterio non soltanto quantitativo che ci consente di parlare di villaggi, di paesi o di città Così, se tu parli di un paese, noi ci aspettiamo di vedere almeno una strada su cui le case si affaccino segnando una discontinuità con i campi che le attorniano, e ci attendiamo anche che quella strada si incontri con altre o che abbia, nel centro, una piazza che sia per tutti un luogo comune. Se poi le strade si intrecciano con altre strade, e se i vicoli si affiancano ai viali, e i viali alle piazze, e le case ai palazzi e ai teatri e ai luoghi di culto, allora non avremo davvero più dubbi.
Qualcosa di simile accade anche nel caso del linguaggio: anche se non possiamo tracciare con esattezza il discrimine che separa i giochi che Wittgenstein ci propone da ciò che chiamiamo linguaggio, ci aspettiamo comunque che un linguaggio abbia una forma sufficientemente articolata. Proprio come vi è una forma che distingue un mucchio di ciottoli dai pochi sassi che gli sono vicini, così vi è una forma del linguaggio che può variare ma che deve essere appunto sufficientemente articolata, — perché tale è il linguaggio degli uomini.
Di qui la terza riflessione che vogliamo proporre e che scaturisce non appena rileggiamo ancora una volta la breve analogia su cui Wittgenstein ci invita a pensare. Parlare del linguaggio come di una città con un centro ed una periferia vuol dire infatti richiamare l'attenzione sulla relazione che lega il linguaggio alla forma di vita degli uomini e le sue regole alle certezze che la sorreggono.
Le Ricerche Logiche di Ludwig Wittgenstein
IntroduzioneLudwig Wittgenstein, una delle figure più influenti nella filosofia del XX secolo, ha dedicato gran parte della sua riflessione alle questioni logiche e linguistiche. La sua opera si divide tradizionalmente in due grandi periodi: il "primo Wittgenstein", rappresentato principalmente dal Tractatus Logico-Philosophicus, e il "secondo Wittgenstein", incarnato dalle Ricerche Filosofiche (Philosophische Untersuchungen). Entrambi i periodi offrono contributi fondamentali alla logica, alla filosofia del linguaggio e alla filosofia della mente, sebbene lo facciano da prospettive profondamente diverse. In questo saggio esploreremo in modo approfondito le ricerche logiche di Wittgenstein, analizzando sia il suo approccio iniziale alla logica come struttura formale del linguaggio e del mondo, sia la successiva revisione di tali concezioni alla luce della pratica linguistica ordinaria.
Capitolo 1: Il Contesto Filosofico del TractatusPer comprendere pienamente le tesi logiche del Tractatus Logico-Philosophicus, è essenziale situare l'opera nel contesto filosofico e scientifico dell'epoca. All'inizio del XX secolo, la logica formale stava vivendo una rivoluzione grazie ai lavori di Frege, Russell e Whitehead. Wittgenstein si inserisce in questo panorama come un pensatore che intendeva chiarire il rapporto tra linguaggio, pensiero e realtà.
Il Tractatus mira a delineare i limiti del linguaggio e, attraverso questo, i limiti del pensabile. La struttura dell'opera è aforistica, con proposizioni numerate gerarchicamente che intendono rappresentare la struttura logica della realtà. In particolare, Wittgenstein sviluppa una teoria raffigurativa del linguaggio: le proposizioni significative sono immagini della realtà, nel senso che condividono con essa una forma logica.
Capitolo 2: La Teoria Raffigurativa del LinguaggioUna delle idee centrali del Tractatus è che il linguaggio possa "raffigurare" fatti nel mondo. Una proposizione è un modello della realtà, e il modo in cui i suoi componenti sono ordinati riflette la struttura del fatto che essa descrive. Questa teoria si basa sull'assunzione che vi sia una "forma logica" comune tra il linguaggio e il mondo. Come afferma Wittgenstein nella proposizione 2.1: "Siamo in possesso di una rappresentazione della realtà nel linguaggio."
Questa concezione ha importanti conseguenze per la logica. Se il linguaggio può raffigurare la realtà, allora la logica è il fondamento stesso di questa possibilità rappresentativa. La logica non descrive il mondo, ma ne mostra la struttura. È, secondo Wittgenstein, trascendentale: non può essere detta, ma solo mostrata. Questo porta alla famosa affermazione: "Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere."
Capitolo 3: Il Linguaggio, la Logica e i Limiti del PensieroNel Tractatus, Wittgenstein propone una visione fortemente delimitativa del linguaggio e del pensiero. Le proposizioni della logica non sono descrittive, ma mostrano le condizioni di possibilità della rappresentazione. La logica, in quanto tale, è priva di contenuto, ma è la forma in cui ogni contenuto deve presentarsi per essere pensabile.
Questa impostazione ha implicazioni metafilosofiche. Il Tractatus è, secondo la celebre immagine di Wittgenstein, una scala che si deve abbandonare dopo averla usata per salire. Le sue proposizioni sono strumenti per vedere il mondo più chiaramente, ma non hanno valore di verità nel senso consueto.
Capitolo 4: Critiche e Sviluppi SuccessiviDopo la pubblicazione del Tractatus, Wittgenstein si ritira dalla filosofia, convinto di aver risolto i problemi fondamentali. Tuttavia, con il tempo, egli stesso riconosce le insufficienze del proprio lavoro. La rigida distinzione tra ciò che può essere detto e ciò che può solo essere mostrato si rivela problematica, e la teoria raffigurativa del linguaggio non riesce a rendere conto adeguatamente della complessità dell'uso linguistico. Negli anni '30, Wittgenstein torna alla filosofia con una prospettiva radicalmente diversa. La logica non è più vista come una struttura trascendentale, ma come parte integrante dell'attività linguistica ordinaria. Questo cambiamento apre la strada alle Ricerche Filosofiche, in cui il linguaggio è analizzato come una molteplicità di giochi linguistici.
Capitolo 5: I Giochi Linguistici e la Nuova Concezione del LinguaggioNelle Ricerche Filosofiche, Wittgenstein propone una concezione del linguaggio fondata sull’idea di "giochi linguistici". Secondo questa nuova prospettiva, parlare un linguaggio è partecipare a un'attività umana regolata da convenzioni, pratiche e regole. Ogni gioco linguistico ha le sue proprie regole, e il significato di una parola è dato dal suo uso nel linguaggio. La logica, in questa nuova ottica, non è un sistema unitario che sottende tutto il linguaggio, ma una delle tante pratiche linguistiche. La nozione di forma logica viene così relativizzata: non esiste una singola logica ideale, ma molteplici logiche possibili, ciascuna legata a uno specifico contesto d'uso. Questa svolta ha conseguenze radicali per la concezione della filosofia stessa. La filosofia non è più vista come una disciplina che scopre verità eterne, ma come un’attività terapeutica che mira a dissolvere i problemi filosofici mostrando le confusioni linguistiche da cui derivano.
Capitolo 6: La Logica come Pratica UmanaNel secondo Wittgenstein, la logica viene reinserita all'interno della vita umana. Non è più una struttura a priori del pensiero o della realtà, ma una pratica tra le altre, regolata dalle convenzioni del linguaggio. Questo non significa che la logica venga abbandonata, ma che essa viene ripensata come uno strumento flessibile, al servizio della comunicazione e della comprensione. La logica, quindi, non impone rigidamente la forma del discorso, ma si adatta alle esigenze dei diversi contesti. Le regole logiche non sono presupposti metafisici, ma strumenti normativi che emergono e si consolidano nell’uso. La coerenza e la validità diventano così concetti pragmatici, legati all’efficacia del linguaggio nel contesto della vita quotidiana.
Capitolo 7: Il Concetto di Regola e la Logica dell’IntendereUno dei temi centrali del secondo Wittgenstein è la questione del seguire una regola. Egli si interroga su cosa significhi comprendere ed eseguire correttamente una regola logica o linguistica. Questa indagine ha una profonda rilevanza per la logica, perché mostra che il significato di una regola non risiede in una qualche interpretazione interna, ma nella prassi condivisa degli utenti del linguaggio. Wittgenstein osserva che non esiste un fatto interno o mentale che garantisca che una regola sia stata seguita correttamente. Il seguire una regola è una pratica pubblica, che trova la sua giustificazione nella continuità e nella coerenza del comportamento linguistico. Così, la logica dell’intendere non si fonda su corrispondenze mentali, ma sulla possibilità di spiegare e giustificare l’uso di un’espressione all’interno di una comunità linguistica. Questa concezione mina l’idea classica della logica come sistema chiuso e autosufficiente. La logica non ha un fondamento ultimo, ma si sostiene sulle abitudini condivise del parlare e dell’agire. In questo senso, essa è immanente alla forma di vita umana, e non trascendente.
Capitolo 8: L’Eredità delle Ricerche LogicheLe riflessioni di Wittgenstein sulla logica hanno avuto un impatto duraturo e profondo. Esse hanno spostato l’attenzione dalla ricerca di fondamenti metafisici o assiomatici alla descrizione dell’uso reale del linguaggio. Molti filosofi successivi, come Quine, Sellars, Kripke e Dummett, hanno ripreso e sviluppato le intuizioni wittgensteiniane, pur muovendosi in direzioni diverse. In ambito logico, la lezione di Wittgenstein ha contribuito alla nascita della filosofia del linguaggio ordinario e al rinnovato interesse per la pragmatica e per l’analisi conversazionale. Inoltre, ha influenzato approcci alternativi alla logica classica, come la logica paraconsistente, la logica fuzzy e le logiche dialogiche, che cercano di modellare più fedelmente le pratiche discorsive umane. La concezione wittgensteiniana della logica come attività regolata e contingente ha aperto nuovi orizzonti non solo alla filosofia, ma anche alla linguistica, alla semiotica e alla scienza cognitiva, dove si cercano modelli più flessibili e dinamici per comprendere il linguaggio e il pensiero.
Capitolo 9: Logica, Intenzionalità e MenteUno degli aspetti più innovativi della riflessione di Wittgenstein, soprattutto nel periodo delle Ricerche Filosofiche, è il modo in cui lega la logica alla nozione di intenzionalità e alla filosofia della mente. In opposizione all'idea che l'intenzionalità sia un fatto mentale interno o una relazione causale, Wittgenstein propone un approccio in cui il significato intenzionale nasce dall'uso contestualizzato di parole e gesti. La logica non è separabile dalla capacità di comprendere intenzioni, domande, ordini e affermazioni, tutte espressioni che assumono significato solo in una forma di vita condivisa. La mente, allora, non è un luogo privato inaccessibile, ma un insieme di pratiche che si esprimono pubblicamente attraverso il linguaggio. In questo modo, Wittgenstein smonta l’idea che l’intenzionalità possa fondare la logica in termini mentali. Al contrario, è la logica dell’interazione sociale, del linguaggio ordinario e delle forme di vita che permette di parlare di intenzioni e significati. Questo porta a una visione più umana e meno formalistica della razionalità e del ragionamento.
ConclusioneL’opera logica di Ludwig Wittgenstein rappresenta un percorso filosofico eccezionale, che va dalla costruzione di un sistema rigoroso e formale fino alla sua decostruzione attraverso l’analisi delle pratiche linguistiche quotidiane. Dal Tractatus alle Ricerche Filosofiche, Wittgenstein ci invita a riflettere sulla natura del linguaggio, del pensiero e della logica, non come realtà isolate e trascendenti, ma come fenomeni immersi nella vita umana.
La sua eredità continua a stimolare il dibattito filosofico contemporaneo, ponendo interrogativi fondamentali su che cosa significhi capire, comunicare e ragionare. In definitiva, la logica secondo Wittgenstein non è solo una disciplina astratta, ma un elemento vivo del nostro essere nel mondo.