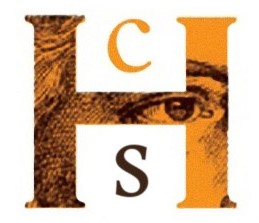Lessico greco della filosofia
adikia (he) / ἀδικία (ἡ), l'ingiustizia → dikaiosyne.
agathon (to) / ἀγαθόν (τό), il Bene.
Neutro sostantivato dell'aggettivo agathos / ἀ-γαθός, buono; superlativo, to ariston / τὸ ἄριστον; il Sommo Bene; latino: summum bonum.
Nella filosofia greca, il Bene è l'obiettivo che si offre a ciascun uomo per dare un senso alla propria vita. È fonte di felicità (eudaimonia), ricerca incessante dell'anima. Ma solo il sapiente può raggiungere il Bene, perché è il solo a saper utilizzare in modo adeguato la ragione. Tuttavia, nessun filosofo pare aver raggiunto il fine della sua ricerca (il che giustifica il significato della parola filosofo, "colui che ama il sapere" e che lo cerca poiché non lo ha trovato), in quanto sono tutti in disaccordo sulla natura del Bene.
agencia / ἀγένεια, il presente infinito cratere. Il Signore = Dio.
aggettivo. ἀγγαρεύω, senza inizio (ἰ ἀγγαρεύω).
aidios / ἀΐδιος, eterno.
Dell'eternità e del tempo, Peri aionos kai chronou / Περὶ αἰῶνος καὶ χρόνου (III, VII), nel quale fa dell'eternità un Essere della stessa natura degli intelligibili.
aion / αἰών, eternità, spesso impiegato come sinonimo.
aionios / αἰώνιος, eterno.
Da qui l'aggettivo "eterno", che spesso indica non la durata eterna nel tempo, ma piuttosto nell'ordine della struttura del tempo (ciò che rientra nella relazione Dio/creazione).
aisthesis (he) / αἴσθησις (ἡ), la sensazione; latino: sensus.
La parola ha due significati: facoltà di sentire (sensibilità) e atto del sentire (sensazione).
Inoltre, essa comprende non solo ciò che noi chiamiamo sensazione (conoscenza sensoriale di una qualità), ma anche ciò che chiamiamo percezione (conoscenza sensoriale di un oggetto).
Aristotele distingue nettamente i due significati, affermando che il termine può significare sia il sentire in potenza (aver la facoltà), sia il sentire in atto. Nell'atto, si nota un'azione dell'identico sull'identico: l'occhio vede il visibile, l'orecchio sente l'udibile (L'Anima, II, 5). Quest'oggetto che riceve l'azione è il sentito: aistheton (αἰσθητόν).
Da questa parola deriva il termine "estetica"; nell'"Estetica trascendentale", prima parte della Critica della ragion pura, Kant tratta infatti di una filosofia della conoscenza sensibile.
È il processo conoscitivo che consiste nell'acquisizione di un oggetto mediante gli organi dei sensi; la percezione è l'acquisizione del dato sensibile compiuta dall'anima. L'aisthēsis è il primo grado della conoscenza, seguito dall'epistēmē (opinione) e dall'epistēmē (scienza).
aitía (aītia in Aristotele) è essenza.
Anche: cfr. aitialízata patáa, la decisione o susseguenza del moto delle cause che concorrono alla realizzazione di susseguence eterne. Cfr. zoon ahīon [tit. 37b].
akatalēpsía / ἀκαταληψία
È l'impossibilità di accettare definitive della scuola. Termine centrale nella filosofia scettica, indica l'impossibilità di raggiungere una conoscenza certa e definitiva della realtà. Gli scettici, in particolare Pirrone e Sesto Empirico, sostenevano che ogni tentativo di conoscenza definitiva è destinato al fallimento.
basileia (he) / βασιλεία (ἡ), la sovranità.
Aristotele distingue due tipi di sovranità quella assoluta che volge in tirannia, e quella relativa, come a Sparta (Politica, III, XIV-XV). Restano, del periodo ellenistico, tre trattati sulla sovranità (Peri basileias) dovuti a neopitagorici: Efante, Diotogene e Stenida.
boule (he) / βουλή (ἡ), la deliberazione.
Segno della libertà di scelta (proairesis) che presiede all'azione virtuosa (Aristotele, Etica Nicomachea, III, III). Politica: il Consiglio della Città (che delibera) (Aristotele, Politica, VI, III, IV, VIII).
boulesis / βούλησις (ἡ), la volontà.
Volontà spontanea, diversa dalla volontà deliberata (proairesis). È in un certo senso un desiderio affermato, che non obbedisce alla ragione (Platone, Leggi, III, 687e). «La boulesis» dice Aristotele «concerne il fine da raggiungere; la
eph'hemin
ciò che è al di là dell'intelligibile, occorre accantonare tutti gli intelligibili.
eph'hemin (ta) / ἐφ'ἡμῖν (τά), ciò che è in nostro potere
Locuzione stoica che indica la limitazione della libertà: «Ciò che è in nostro potere è l'opinione (hypolesis), la tendenza (orexis), l'inclinazione (ekklisis)» (Manuale, I, 1). Il contrario è «ciò che non è in nostro potere» ta ouk eph'hemin / τὰ οὐκ ἐφ' ἡμῖν.
epieikeia (he) / ἐπιείκεια (ἡ), l'equità
Giusta applicazione agli individui di una legge a loro oscura (Aristotele, Etica Nicomachea, V, X, 1-8).
episteme (he) / ἐπιστήμη (ἡ), la scienza; latino: scientia
La scienza, conoscenza dell'universale. Secondo le differenze del pensiero metafisico, l'oggetto della scienza varia: l'universale è o una realtà trascendente all'intelligenza, oppure un concetto nell'intelligenza.
Per Platone, la scienza ha come oggetto il Mondo delle Idee.
eidos (to) / εἶδος (τό), l'essenza, l'idea, la forma, il genere, la specie; latino: species, forma, essentia
La parola eidos ha molteplici significati, che comprendono in ogni caso la nozione di generalità, che si trova negli esseri o nell'intelligenza.
Eidos deriva dal verbo arcaico e poetico eidomai / εἴδομαι, appaio (sono visto); da qui il senso originario di eidos, l'aspetto, l'apparenza. Il perfetto dell'inusitato eido / εἴδω (oida / οἶδα), assume un significato presente: io so. Solo in età tarda e in modo marginale eidos ha adottato un significato filosofico; il termine latino species, che indica insieme aspetto e specie, è quello che rende meglio il duplice senso. Lo stesso senso filosofico può assumere significati diversi metafisico, fisico, psicologico, logico.
1) Significato metafisico. L'essenza degli esseri. Può essere di due tipi.
a) Trascendente alle cose. È il significato platonico. Le Essenze formano il Mondo intelligibile. Esse sono le vere Realtà (Fedro, 247c), esistono in sé (Fedone, 75d), e per sé (ivi, 65c, 78d).
enkrateia (he) / ἐγκράτεια (ἡ), il dominio di sé
Termine specificamente stoico (Epitteto, Manuale, X).
epagoge (he) / ἐπαγωγή (ἡ), l'induzione
Logica. Ragionamento che va dal singolare al generale. Lo studio dell'induzione è sviluppato da Aristotele negli Analitici primi (II, 23).
entelecheia (he) / ἐντελέχεια (ἡ), l'entelecheia; latino: actus
L'atto (energeia) nella sua compiutezza.
Composto da telos / τέλος, che significa il "fine", il termine indica una certa perfezione. In Aristotele, che ne inaugura l'impiego, assume tuttavia due significati: a) è sinonimo di energeia; b) è perfezione dell'energeia.
Nel libro Θ della Metafisica, Aristotele oppone la potenza (dynamis) all'entelecheia, definendo quest'ultima come potenza attiva.
epekeina / ἐπέκεινα, al di là, avverbio e preposizione
Indica la trascendenza assoluta: « Il Bene è al di là dell'Essere (ousia / οὐσία) » (Platone, Repubblica, VI, 509b). « L'Uno è al di là di tutte le cose, e dell'Intelletto» (Plotino, V, III, 13); «al di là dell'Essere» (VI, II, 3). «Ciò che è al di là dell'Essere (ousia) è anche al di là del pensiero» (to noein / τὸ νοεῖν) (ivi, V, VI, 6). «Per vedere...»
euthymia (he) / εὐθυμία (ἡ), il benessere
Democrito poneva il bene supremo nel benessere (D.L., IX, 45). Secondo Seneca, questo è un altro nome dato dagli stoici all'ataraxia (De tranquillitate animi, II).
logos (to) / λόγος (ὁ), la ragione; latino: ratio
La ragione, facoltà intellettiva dell'uomo, considerata come suo carattere specifico, e tutte le forme della sua attività.
Il primo significato di logos (dal verbo legein / λέγειν, parlare) è parola, linguaggio. Ora, il linguaggio è espressione del pensiero. Il capitolo IV del trattato aristotelico Dell'interpretazione parla del discorso: logos. In realtà, la parola logos possiede un significato pieno di sfumature, che possiamo suddividere in:
– la facoltà mentale superiore, sinonimo d'intelligenza concettuale e ragiocinante (→ nous);
– il ragionamento;
– il concetto.
• Facoltà. Questo significato è usato fin dalle origini. Pitagora suddivide l'anima umana in due parti: una è dotata di ragione, l'altra ne è priva. La prima è incorruttibile (Aezio, IV, IV, 1; V, 10, 1). Stessa distinzione in Aristotele (Etica Nicomachea, VI, I, 5), che spiega che è il logos che conosce l'universale (katholou), oggetto della scienza (Fisica, I, 5). Platone divide l'anima in tre parti.
phainomenon (to) / φαινόμενον (τό), l'apparenza; latino: species; plurale phainomena
Quel che appare della realtà. Al plurale, talora, significa gli eventi.
Participio neutro sostantivato del verbo phainestai (prima persona singolare: phainomai): apparire. È dunque solo quello che i sensi conoscono della cosa. La nozione abituale indica un'insufficienza (l'apparenza non ci fa conoscere la realtà) o anche un'illusione (l'apparenza tradisce la realtà).
L'impiego del termine risulta raro fino ad Aristotele. Lo si trova una volta in Anassagora: «Le apparenze sono il volto dell'invisibile» (fr. 21a), e qualche volta in Platone: le opere d'arte sono...
syllogismos (ho) / συλλογισμός (ό), il sillogismo
Logica. È il tipo stesso del ragionamento deduttivo, di cui Aristotele definisce le regole negli Analitici primi.