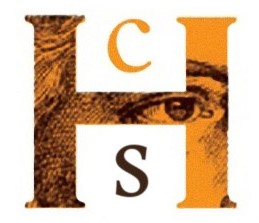Introduzione - Critica della Ragion Pura
I. Intorno alla differenza fra conoscenza pura e conoscenza empirica
Non c’è dubbio che ogni nostra conoscenza incomincia con l’esperienza; da che mai infatti la nostra facoltà di conoscere sarebbe altrimenti messa in moto se non da parte di oggetti che colpiscono i nostri sensi, e che da un lato determinano da sé le rappresentazioni, mentre dall’altro mettono in moto l’attività del nostro intelletto a raffrontare queste rappresentazioni, a unire o a separare, ad elaborare in tal modo la materia prima delle impressioni sensibili, in vista di quella conoscenza degli oggetti che si chiama esperienza.2
Quanto al tempo, pertanto, nessuna conoscenza precede in noi l’esperienza e tutte incominciano con essa.
Ma benché ogni nostra conoscenza cominci con l’esperienza, da ciò non segue che essa derivi interamente dall’esperienza. Potrebbe infatti avvenire che la nostra stessa conoscenza empirica sia un composto di ciò che riceviamo mediante le impressioni e di ciò che la nostra facoltà cognoscitiva vi aggiunge da sé sola (semplicemente stimolata dalle impressioni sensibili); aggiunta, questa, che non si distingue da quella materia prima, se non che a lungo esercizio non ce ne abbiano resi esperti, potendo in grado di separarle e giudicarle due fattori.4
Essa è stata redatta in questa forma nella seconda edizione della Critica; nella prima essa era più breve e sviluppava meno analiticamente alcuni punti messi meglio a fuoco. Anche questo testo tuttavia, bello e fondamentale, comporta partire da sezioni insiemi assai differenziati, per far sì che il lettore si orienti meglio su equilibri e forme dell’opera; in particolare è proficuo non scegliere solo alcuni temi, ma non da tutti i fondamenti; senz’altro preferibile, però che come sottolinea Kant, gli argomenti sono sviluppati soprattutto nell’Analitica e infine, perché, come si vedrà nella logica: com’è stato suggerito, vi è lui nuovo ed evidente la distinzione formale.
La nostra conoscenza non deriva interamente dall’esperienza, ma solo da un punto di vista cronologico, tale concezione è assunta da Kant come un punto di partenza non ulteriormente indagato. È da notare che in questo passo il termine «esperienza», ricorre a proposito due volte: nella prima occorrenza è il mero materiale dei sensi, alla seconda invece la finale, elaborata costruzione conoscitiva nel senso od intelletto hanno adottata.
A questo punto si può aggiungere, con il dell’Estetica ed indica semplicemente l’ordine cronologico con cui la conoscenza ha luogo.
Vi è dunque almeno una questione bisognosa di ulteriore esame e di cui non è possibile sbrigarsi a prima vista, cioè se esista una simile conoscenza, indipendente dall’esperienza e da ogni impressione sensibile. Conoscenze siffatte sono dette a priori, e sono distinte dalle empiriche, che hanno la loro sorgente a posteriori, ossia nell’esperienza.
Tuttavia l’espressione «a priori» non è ancora sufficientemente determinata per designare adeguatamente l’intero significato della questione in esame. Si suole infatti dire, nei riguardi di molte conoscenze derivate da fonti empiriche, che noi siamo capaci a predirci a priori, per il fatto che noi le ricaviamo immediatamente, senza esperienza, bensì da una regola universale, che nondimeno abbiamo assunto dall’esperienza. Così di uno che abbia scavalcato il tetto di una casa si suole dire che egli avrebbe ben dovuto sapere a priori che la casa sarebbe caduta, senza aver bisogno cioè di attendere che la cosa fosse accaduta nell’esperienza. Ma pur sempre egli non poteva sapere interamente a priori; egli aveva infatti bisogno di sapere anticipatamente, ma per esperienza, che i corpi sono pesanti e che cadono quando si viene a mancare l’appoggio.
D’ora innanzi considereremo dunque conoscenze a priori non quelle che si costituiscono indipendentemente da questa o quell’esperienza, ma quelle che risultano assolutamente indipendenti da ogni esperienza. Ad esse vengono contrapposte le conoscenze empiriche, cioè tali da essere possibili soltanto a posteriori, ossia mediante l’esperienza. Delle conoscenze a priori si chiamano poi pure quelle a cui non si mischia nulla di empirico. Ad esempio, la proposizione: «Ogni mutamento ha la sua causa», è una proposizione a priori, ma tuttavia non pura, perché il mutamento è un concetto che può derivare soltanto dall'esperienza.
II. Noi possediamo alcune conoscenze a priori, e lo stesso intelletto comune non ne è mai privo.
Ciò che ora ci occorre è un segno distintivo per separare con sicurezza una conoscenza pura da una conoscenza empirica. Certamente l'esperienza ci insegna il modo in cui una cosa è fatta, ma non che essa non può essere fatta diversamente. In primo luogo, dunque, se una proposizione è pensata assieme alla sua necessità, è un giudizio a priori; se per di più deriva esclusivamente da un'altra proposizione che abbia a sua volta valore di proposizione necessaria, la proposizione è assolutamente a priori. In secondo luogo, l'esperienza non conferisce mai ai suoi giudizi una universalità autentica e rigorosa, ma semplicemente una universalità presunta e comparativa (per induzione) sì che si deve propriamente dire: stando a quanto abbiamo finora osservato, non risulta alcuna eccezione a questa regola. Quando dunque un giudizio sia pensato con rigorosa universalità, cioè in modo tale da non tollerare eccezioni di alcun genere, esso non deriva dall'esperienza, ma è valido assolutamente a priori. L'universalità empirica non è dunque altro che un'estensione arbitraria in fatto di validità, da quella che poggia sul maggior numero dei casi a quella che vale in ogni caso, come ad esempio nella proposizione: «Tutti i corpi sono pesanti». Per contro, se un giudizio porta con sé una rigorosa universalità, questa sta a manifestare una fonte particolare di conoscenza, ossia una facoltà di conoscenza a priori. Necessità e rigorosa universalità sono pertanto i segni sicuri della conoscenza a priori e si implicano reciprocamente in modo inscindibile9. [...]
Orbene, è facile dimostrare che nella conoscenza umana si danno effettivamente simili giudizi, necessari e universali nel senso più rigoroso, e quindi puri a priori. Se si vuole un esempio ricavato dalle scienze, non si deve far altro che prendere in considerazione tutti i giudizi della matematica; se si vuole un esempio dell'uso più comune dell'intelletto, può servire la proposizione: «Ogni mutamento deve avere una causa». se si vogliono invece esempi ricavati dal più comune uso dell'intelletto, può bastare la proposizione che ogni mutamento deve avere una causa; in questa proposizione, anzi, il concetto stesso di una causa contiene così palesemente il concetto di una necessità della connessione con l'effetto e di una rigorosa universalità della legge, che esso andrebbe del tutto perduto se si pretendesse ricavarlo, come fece Hume, dalla ripetuta associazione di ciò che accade con ciò che precede e dalla conseguente abitudine (e perciò da una necessità semplicemente soggettiva) di connettere alcune rappresentazioni. Anche senza far ricorso a esempi del genere per stabilire la effettiva sussistenza di principi a priori della nostra conoscenza, si potrebbe semplicemente dimostrare che essi sono indispensabili per la stessa possibilità della nostra esperienza, dandone così una prova a priori10. Donde mai, infatti, l'esperienza trarrebbe la sua certezza se le regole secondo cui essa procede fossero in ogni caso empiriche, quindi contingenti? Come potrebbero, in questo caso, fungere da principi? Ma qui possiamo accontentarci di aver esposto come un fatto l'uso puro della nostra facoltà di conoscere, assieme ai segni che lo contraddistinguono. Non solo però nei giudizi, ma anche nei concetti si rivela l'origine a priori di alcuni di essi. Se infatti togliete a poco a poco dal concetto di un corpo, fornitovi dall'esperienza, tutto ciò che vi è di empirico, ossia il colore, la durezza, la mollezza, il peso e la stessa impenetrabilità, rimane pur sempre lo spazio che il corpo (che si è ora del tutto dileguato) occupava, spazio che non può essere soppresso. Egualmente, se sottraete al vostro concetto empirico di un qualsiasi oggetto, corporeo o non corporeo, tutte le proprietà insegnatevi dall'esperienza, non vi è tuttavia possibile sottrarre quella mediante cui lo pensate come sostanza o come inerente a una sostanza (benché questo concetto possegga una determinazione maggiore di quello di oggetto in generale). Guidati dalla necessità con cui questo concetto vi si impone, non potete non riconoscere che esso ha la sua sede nella vostra facoltà di conoscere a priori.
IV. Intorno alla distinzione dei giudizi in sintetici e analitici.
In tutti i giudizi in cui è pensato il rapporto fra un soggetto e un predicato11 (considero qui soltanto gli affermativi, poiché l'applicazione ai negativi risulta poi facile) questo rapporto è possibile in due modi diversi. O il predicato B appartiene al soggetto A come qualcosa che è contenuto (dissimulatamente) in questo concetto A; oppure B si trova totalmente al di fuori del concetto A, pur essendo in connessione con esso. Nel primo caso dico il giudizio analitico12, nel secondo sintetico13. Giudizi analitici (affermativi) sono pertanto quelli in cui la connessione del predicato col soggetto è pensata per identità, mentre quelli in cui la connessione è pensata senza identità, si debbono chiamare sintetici. I primi potrebbero anche esser detti giudizi esplicativi, gli altri ampliativi; i primi infatti, mediante il predicato, nulla aggiungono al concetto del soggetto, limitandosi a dividere, per analisi, il concetto nei suoi concetti parziali, che erano in esso già pensati (benché confusamente); i secondi, invece, aggiungono al concetto del soggetto un predicato che in quello non era minimamente pensato e che non poteva esserne ricavato mediante alcuna scomposizione. Se dico, ad esempio: «Tutti i corpi sono estesi», si tratta di un giudizio analitico; non ho infatti bisogno di andare al di là dal concetto che collego alla parola «corpo» per rintracciare l'estensione che ad esso si connette, ma mi è sufficiente scomporre quel concetto, ossia rendermi conto del molteplice che io penso sempre in esso contenuto, per ritrovarvi questo predicato; si tratta dunque di un giudizio analitico. Al contrario, se dico: «Tutti i corpi sono pesanti», allora il predicato è qualcosa di completamente diverso da ciò che io penso nel semplice concetto di corpo in generale. L'aggiunta d'un tal predicato ci dà quindi un giudizio sintetico.
I giudizi d'esperienza, come tali, sono tutti sintetici. Sarebbe infatti assurdo fondare un giudizio analitico sull'esperienza, quando, per formulare il giudizio, non ho alcun bisogno di uscire dal mio concetto, e non mi occorre pertanto alcuna testimonianza dell'esperienza. Che un corpo sia esteso, è una proposizione che sta salda a priori e non un giudizio d'esperienza. Infatti, prima ancora di accedere all'esperienza, posseggo tutte le condizioni del mio giudizio già nel concetto, dal quale non ho che da ricavare il predicato secondo il principio di contraddizione, e così acquistare coscienza della necessità del giudizio, che mai potrebbe derivarmi dall'esperienza. Al contrario, benché nel concetto di un corpo in generale io non includa di già il predicato della pesantezza, tuttavia14 quel concetto designa un oggetto dell'esperienza mediante una parte di essa, a cui io posso quindi aggiungere ulteriori parti della medesima esperienza, che non appartenevano al concetto. Posso, in un primo tempo, conoscere il concetto di corpo analiticamente, tramite le note dell'estensione, dell'impenetrabilità, della forma, ecc., che sono tutte pensate dentro questo concetto. Successivamente estendo però la mia conoscenza e, ricorrendo nuovamente all'esperienza da cui avevo tratto questo concetto di corpo, trovo che alle note suddette va sempre connessa anche quella della pesantezza e l'aggiungo quindi sinteticamente, come predicato, a quel concetto. E dunque l'esperienza ciò su cui si fonda la possibilità della sintesi tra il predicato della pesantezza e il concetto del corpo, perché i due concetti, benché uno non sia contenuto nell'al-tro, appartengono tuttavia, se pur solo accidentalmente, l'uno all'altro come parti di un tutto, cioè dell'esperienza. Ma nel caso dei giudizi sintetici a priori!5 questo punto di appoggio manca del tutto. Se debbo procedere oltre il concetto A per conoscerne un altro B, come ad esso legato, in cosa consisterà ciò su cui mi fondo e mediante cui la sintesi è resa possibile? Qui infatti non ho il vantaggio di poter ricorrere alla guida dell'esperien-za. Si prenda la proposizione: «Tutto ciò che accade ha una causa». Nel concetto di «qualcosa che accade», in verità io penso un'esistenza, preceduta da un tempo ecc., dal che è possibile ricavare giudizi analitici. Ma il concetto di causa giace interamente fuori da quel concetto e designa qualcosa di diverso da ciò che accade e non è quindi per nulla contenuto in quest'ultima rappresentazione. Come mai dunque io giungo ad affermare, di qualcosa che accade in generale, alcunché di affatto diverso, ed a considerare il concetto di causa, sebbene non contenuto in quello, tuttavia come in esso rientrante, e addirittura necessariamente? Che cos'è in questo caso l'incognita x su cui l'intelletto si appoggia, allorché crede di rintrac- versalità maggiore, ma anche con la nota della necessità, quindi interamente a priori, nonché in base a semplici concetti. Ora, è su tali principi sintetici. cioè estensivi, che riposa l'intero scopo finale delle nostre conoscenze speculative a priori 6; perché gli analitici, pur essendo estremamente importanti e necessari, lo sono esclusivamente per giungere a quella chiarezza dei concetti che è richiesta per una sintesi sicura ed ampia, come per un'acquisizione realmente nuova. V. In tutte le scienze teoretiche della ragione sono inclusi, come principi, giudizi sintetici a priori. 1. I giudizi matematici sono tutti sintetici " . Questa proposizione, per quanto sia indubitabilmente certa e ricca di conseguenze, pare sia finora sfuggita alla considerazione di quanti hanno analizzato l'umana ragione, anzi sembra contrapporsi del tutto alle loro congetture. Infatti, poiché si riscontrò che i ragionamenti dei matematici procedono tutti secondo il principio di contraddizione (come è richiesto dalla natura di ogni certezza apodittica), si credette che anche i principi fossero conosciuti in virtù del principio di contraddizione; si trattava però d'un errore, perché una proposizione sintetica può certamente esser conosciuta secondo il principio di contraddizione, ma solo se si presuppone un'altra proposizione sintetica, da cui possa esser ricavata; non mai, dunque, in se stessa 18 Occorre prima di tutto tener presente che le autentiche proposizioni matematiche sono sempre giudizi a priori, e non empirici, in quanto portano con sé quella necessità che non può mai esser tratta dall'esperienza. Se non lo si vuol concedere, ebbene, limito allora la mia affermazione alla matematica pura, nel cui concetto è già implicito che non contiene conoscenze empiriche, ma esclusivamente una conoscenza pura a priori. In verità, a prima vista, si potrebbe pensare che la proposizione 7+5=12 sia una proposizione semplicemente analitica, derivante dal concetto di una somma di sette e cinque in base al principio di contraddizione. Ma, se si considera più da vicino la cosa, risulta chiaro che il concetto della somma di 7 e 5 altro non racchiude se non l'unione dei due numeri in uno solo, il che non implica per nulla che si pensi quale sia quest'unico numero che racchiude gli altri due. Il concetto di dodici non è per nulla pensato per il fatto che io pensi semplicemente quella unione di 7 e 5, ed ho un bell'analizzare il mio concetto di una tale somma possibile, ma non vi ritroverò mai il numero dodici 19 .È necessario andare al di là di questi concetti, facendo appello all'intuizione 2º che corrisponde a uno dei due numeri, ad esempio alle proprie cinque dita o a cinque punti [...] ed aggiungere, 'una dopo l'altra, al concetto del sette le unità del numero cinque quale è dato nell'intuizione. Difatti, io prendo prima di tutto il numero 7 e, servendomi delle cinque dita della mia mano come intuizione del concetto del 5, procedo ad aggiungere successivamente, in base a quell'immagine, al numero 7 tutte le unità che precedentemente avevo riunite per dar luogo al numero 5, e vedo così costituirsi il numero 12. Che 5 si dovesse aggiungere a 7 l'ho certamente pensato nel concetto di una somma 7+5, ma non ho pensato che questa somma sia eguale al numero 12. La proposizione aritmetica è dunque sempre sintetica; il che si fa tanto più evidente quanto più grandi sono i numeri presi in considerazione, risultando allora chiaro che noi, per quanto giriamo e rigiriamo i nostri concetti, senza l'aiuto dell'intuizione non potremmo mai trovare la somma con la semplice analisi di tali concetti. Altrettanto poco analitico è qualsiasi principio della geometria pura 21 . Che la retta sia la linea più breve fra due punti, è una proposizione sintetica. Infatti il mio concetto del retto non contiene nulla in fatto di quantità, ma solo una qualità. Il concetto del più breve, perciò, è interamente aggiunto, e non può esser tratto, mediante una qualsiasi analisi, da quello della linea retta. Qui deve venir in soccorso l'intuizione perché solo essa può render possibile la sintesi. Solo poche proposizioni fondamentali presupposte dai geometri sono, in verità, effettivamente analitiche e poggiano sul principio di contraddizione, ma, come tutte le proposizioni analitiche, a null'altro servono che all'articolazione del meto-do, senza poter valere come principi. Tali sono, ad esempio, a - a, il tutto è eguale a se stesso; oppure (a + b > a), ossia il tutto è maggiore di ogni sua parte. Ma anche queste stesse proposizioni, benché valgano in base a semplici concetti, sono accolte in matematica solo perché possono essere esibite nell'intuizione. E semplicemente l'ambiguità dell'espressione a farci credere, in questo caso, che 1l predicato di tali giudizi apodittici sia di già incluso nel nostro concetto e che il giudizio sia quindi analitico. Infatti dobbiamo pensare un certo predicato come aggiunto a un dato concetto, e questa necessità inerisce già ai concetti. Ma la questione non concerne che cosa dobbiamo pensare in aggiunta al concetto dato, bensì che cosa pensiamo realmente in esso, benché solo oscuramente; risulta allora chiaro che il predicato inerisce sì necessariamente a quei concetti, ma non perché pensato nel concetto come tale, bensì mediante l'intuizione, che deve aggiungersi al concetto. 2. La fisica (Physica) include in sé, in qualità di principi, giudizi sintetici a priori 22 . Addurrò, quali esempi, soltanto un paio di proposizioni, come quella che in tutti i cambiamenti del mondo corporeo la quantità di materia resta invariata; oppure l'altra, che in ogni comunicazione di movimento, azione e reazione sono sempre in rapporto di eguaglianza. Per tutte e due le proposizioni, non solo è chiara la necessità e quindi la loro origine a priori, ma è anche chiara la loro natura di proposizioni sintetiche. Infatti, nel concetto di materia io non penso la perma-nenza, ma la sua semplice presenza nello spazio, in quanto lo riempie. Oltrepasso quindi senza dubbio il concetto di materia, per includervi col pensiero qualcosa a priori che non pensavo in esso. Dunque la proposizione non è analitica, ma sinteti-ca, e tuttavia è pensata a priori; lo stesso vale per le altre proposizioni della parte pura della fisica. 3. Nella metafisica, anche se la si considera come una scienza fino ad oggi semplicemente tentata, tuttavia indispensabile alla natura dell'umana ragione, debbono esser contenute conoscenze sintetiche a priori?; in essa non si tratta dunque semplicemente di scomporre e chiarire analiticamente i concetti che ci formiamo a priori delle cose. Ciò che ci proponiamo è invece di estendere la nostra conoscenza a priori, al qual fine dobbiamo servirci di principi tali che aggiungiamo al concetto dato qualcosa in esso non contenuto; mediante giudizi sintetici a priori ci spingiamo così lontano che l'esperienza non può tenerci dietro, come capita, ad esempio, nella proposizione: « Il mondo deve avere un primo cominciamento», ecc. Secondo le sue intenzioni, almeno, la metafisica è costituita di autentiche proposizioni sintetiche. VI. Problema generale della ragion pura. Si ottiene già non poco quando un gran numero di ricerche può essere raccolto sotto forma di un unico problema. In tal modo, infatti, non solo si agevola il nostro lavoro, dandogli una esatta delimitazione, ma si reca giovamento anche a chiunque altro voglia prenderlo in esame per stabilire se siamo riusciti o meno nel nostro intento. Il vero e proprio probiema della ragion pura e pertanto contenuto nella domanda: Come sono possibili giudizi sintetici a priori! Scopo delle CITCA Che la metafisica sia finora rimasta in uno stato cosi oscillante di incertezza e di contraddizioni, non ha altra causa se non il fatto che questo problema, e forse addirittura la differenza fra giudizi sintetici e analitici, non sono stati finora presi in esame. La vita o la morte della metafisica dipendono in realtà dalla soluzione di questo problema o da una dimostrazione fondata che la possibilità di cui richiede la giustificazione è priva di consistenza. David Hume, che si avvicinò più di ogni altro filosofo a questo problema, anche se fu ben lontano dal pensarlo con sufficiente determinatezza e nella sua universalità, essendosi fermato semplicemente alla proposizione sintetica della connessione dell'effetto con le sue cause (principium causalitatis), credette di poterne trarre la conclusione che un tale principio a priori è del tutto impossibile. Stando alle sue conclusioni, tutto ciò che chiamiamo metafisica si risolverebbe nella semplice illusione di conoscere razionalmente ciò che, in realtà, ci proviene dall'esperienza, traendo dall'abitudine l'apparenza della necessità 26 . Mai egli sarebbe scivolato in una affermazione del genere, distruttrice di ogni filosofia, se avesse avuto innanzi agli occhi il nostro problema nella sua universalità; in tal caso, infatti, avrebbe visto che, stando al suo argomento, non potrebbe esistere neppure la matematica pura, dato che essa include certamente principi sintetici a priori: affermazione, questa, dalla quale il suo buon senso lo avrebbe senza dubbio tenuto lontano 27 Nella soluzione del suddetto problema è racchiusa senz'altro la possibilità dell'uso puro della ragione nel fondare e nell'edificare tutte le scienze che contengono una conoscenza teoretica a priori di oggetti, ossia la risposta alle domande: Come è possibile la matematica pura? Come è possibile la fisica pura? Poiché queste scienze sono effettivamente date, conviene di certo domandarsi come siano possibili; infatti, che esse siano possibili è dimostrato dalla loro realtà 28 Quanto alla metafisica, il suo cattivo andamento fino ad oggi, unito al fatto che nessuna delle metafisiche fin qui offerte si può dire che realmente sussista rispetto al suo scopo essenziale, fa dubitare chiunque, a ragione, della sua possibilità. Tuttavia, anche questa specie di conoscenza deve in certo senso esser considerata come data, e la metafisica, anche se non come scienza, è tuttavia reale come disposizione naturale (metaphysica naturalis). Infatti la ragione umana, anche senza il pungolo della semplice vanità dell'omniscienza, e perpetuamente sospinta da un proprio bisogno verso quel problemi che non possono in nessun modo esser risolti da un uso empirico della ragione o in base al principi su cui esso riposa; e così in tutti gli uomini una qualche metafisica è sempre esistita e sempre esisterà appena che la loro ragione si innalzi alla speculazione. Dunque, anche per essa vale la questione: Come è possibile la metafisica in quanto disposizione naturale? Ossia: come scaturiscono dalla natura della ragione umana universale 1 problemi che la ragion pura affronta e a rispondere ai quali, meglio che può, essa è sospinta da un proprio bisogno? Ma poiché si sono sempre riscontrate inevitabili contraddizioni nel rispondere a tali domande naturali - come, ad esempio, a quella se il mondo abbia avuto un cominciamento o esista dall'eternità - non è possibile accontentarsi della semplice disposizione naturale alla metafisica, ossia della pura facoltà della ragione come tale, da cui nasce sempre una qualche metafisica (qualunque essa sia), ma devesi poter giungere sulla sua base a una certezza, o quanto al conoscere e al non conoscere gli oggetti — cioè ad una decisione nei riguardi degli oggetti delle sue questioni → o quanto a un giudizio sulla capacità o incapacità della ragione nei loro riguardi; e pertanto o ad allargare con sicurezza la nostra ragion pura o a fissarle confini precisi e sicuri Quest'ultima domanda, scaturente dal suddetto problema generale, sarebbe a buon diritto la seguente: Come è possibile la metafisica come scienza?" La critica della ragione, alla fine, conduce dunque necessariamente alla scienza; mentre il suo uso dogmatico, privo di critica, conduce ad affermazioni prive di fondamento, alle quali sarà sempre possibile contrapporne altre parimenti fornite di falsa apparenza, sfociando così nello scetticismo. Questa scienza, d'altra parte, non potrà avere un'ampiezza eccessiva e scorag-giante, poiché non ha a che fare con oggetti della ragione, il cui numero è senza confini, ma solo con la ragione stessa, cioè con problemi che sorgono esclusivamente dal suo seno, e sono presentati non dalla natura delle cose, da essa differente, ma dalla natura della ragione stessa 2; così una volta che essa abbia, prima di tutto, imparato a conoscere completamente le proprie capacità conoscitive rispetto agli SOPo oggetti che possono presentarlesi nell'esperienza, potrà agevolmente procedere CSTRUn alla determinazione completa e sicura dell'ambito e dei limiti del proprio uso, SINTES quando tenti di oltrepassare i confini dell'esperienza Si possono e si devono quindi considerare inesistenti tutti i tentativi finora fatti per costruire dogmaticamente una metafisica; infatti quanto vi è nell'una o nell'altra PRIOR metafisica di analitico, ossia la mera scomposizione dei concetti giacenti a priori nella nostra ragione, non è per nulla ancora lo scopo, bensì solo un preparativo, per l'autentica metafisica, cioè per l'estensione sintetica a priori della sua conoscen-za; a tale estensione, la scomposizione non basta, perché si limita a mostrare quanto è già contenuto nei concetti e non il modo in cui noi giungiamo a priori in possesso di tali concetti, e come sia, di conseguenza, possibile determinare anche la validità del loro uso rispetto agli oggetti di ogni conoscenza in generale. Basta solo un po' di abnegazione per rinunciare a tutte queste pretese, visto che le innegabili, e — nel procedimento dogmatico - inevitabili contraddizioni della ragione con se stessa hanno privato già da molto tempo la metafisica della sua reputazione. Sarà però necessaria molta fermezza perché la difficoltà interna e la resistenza esterna non ci distolgano dal promuovere una buona volta la crescita rigogliosa e fruttuosa d'una scienza indispensabile alla ragione umana, facendo ricorso a un procedimento opposto a quello finora impiegato; una scienza dalla quale si potranno sì recidere i rami finora spuntati, ma di cui non si potranno mai svellere le radici. VII. Idea e suddivisione di una scienza speciale, denominata Critica della ragion amamento cristo Da tutto questo deriva ora l'idea d'una scienza speciale, che può prendere il Infatti la ragione» è la facoltà che ci da i nome di Critica della ragion pura 34 principi della conoscenza a priori. Ragion pura è quindi quella che contiene i principi per conoscere qualcosa prettamente a priori. Un organo della ragion pura lopla de sarebbe un insieme di quei principi in base ai quali tutte le conoscenze pure a priori possono essere acquisite ed effettivamente poste in atto. L'applicazione totale d'un primapa tale organo costituirebbe un sistema della ragion pura 36 • Ma poiché questo siste- ma, pur essendo assai richiesto, lascia ancora aperta la questione se anche qui, ed in quali casi, una estensione in generale della nostra conoscenza sia possibile, possiamo allora considerare una scienza della semplice valutazione della ragion dempuce pura, delle sue sorgenti e dei suoi limiti, come la propedeutica al sistema della ragion pura. Una scienza siffatta non dovrebbe chiamarsi dottrina, ma soltanto critica della ragion pura; e, rispetto alla speculazione, la sua utilità sarebbe in realtà solo negativa, poiché servirebbe, anziché all'allargamento, alla semplice purificazione della nostra ragione, liberandola dagli errori; il che è di già un grandissimo dastrane guadagno. Chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupi, in generale, non tanto di oggetti quanto del nostro modo di conoscere gli oggetti nella misura in cui questo deve essere possibile a priori 37 . Un sistema di tali concetti potrebbe esser detto filosofia trascendentale. Ma questa, d'altronde, per cominciare, è ancora troppo. Dovendo infatti tale scienza racchiudere compiutamente tanto la conoscenza analitica quanto la sintetica a priori, viene ad avere un'ampiezza eccessiva rispetto al nostro scopo, che consiste nello spingere l'analisi fin dove è richiesta necessariamente per chiarire in tutta la loro portata i principi della sintesi a priori, cioè l'unica questione che qui ci interessi. Tale ricerca, di cui ora appunto ci occupiamo, non può propriamente esser detta dottrina, ma soltanto critica trascen-dentale, poiche non si propone di ampliare le conoscenze, ma semplicemente di rettificarle e di rintracciare la pietra di paragone per determinare il valore o 1l non valore di tutte le conoscenze a priori. Una tale critica è dunque la preparazione ad un organo, se almeno è possibile; e se ciò non dovesse riuscire, è preparazione almeno ad un canone della ragione, in base al quale, comunque, si potrebbe un giorno esporre, tanto analiticamente che sinteticamente, l'intero sistema della filosofia della ragion pura, — si risolva esso in un'estensione o in una semplice limitazione della relativa conoscenza. Che poi tale sistema sia possibile, che anzi non richieda una ampiezza così grande da togliere la speranza di portarlo a compimen-to, può essere di già desunto dal fatto che con esso non viene posta in questione la natura delle cose, la quale è inesauribile, ma dell'intelletto, che di tale cose giudica, e di esso, inoltre, solo rispetto alla conoscenza a priori; questo patrimonio dell'in-telletto, non dovendo di certo esser cercato fuori di noi, non può restarci nascosto e, secondo ogni previsione, è così ristretto da poter essere rintracciato compiuta-mente, giudicato quanto al suo valore o non valore, e sottoposto a un preciso apprezzamento. Meno ancora ci si può aspettare qui una critica dei libri e dei sistemi della ragion pura; ma piuttosto quella della pura facoltà stessa della ragio-ne. Solo se si pone a fondamento questa critica, si entra in possesso di una sicura pietra di paragone per giudicare del contenuto filosofico di opere antiche e moderne in questo ramo; in caso diverso, storici e giudici privi di competenza procedono a valutare le affermazioni infondate altrui in base alle proprie, non meno infondate. La filosofia trascendentale è l'idea d'una scienza, di cui la critica della ragion pura deve progettare architettonicamente, ossia per principi, l'intero piano, con piena garanzia della completezza e della sicurezza di tutti gli elementi che entrano a costituirne l'edificio. Essa è il sistema di tutti i principi della ragion pura. Se questa critica non prende essa stessa il nome di filosofia trascendentale, dipende dal fatto che, per essere un sistema completo, dovrebbe contenere anche un'analisi particolareggiata di tutta la conoscenza umana a priori. Ora, è fuori dubbio che la nostra critica deve senz'altro presentarci l'esatta enumerazione di tutti i concetti fondamentali che costituiscono la suddetta conoscenza pura; ma giustamente tale critica si astiene dall'analisi di dettaglio di questi concetti, nonché dall'inventario completo di tutti quelli che ne derivano: per un verso, in quanto questa analisi non rientrerebbe nei suoi progetti, non presentando la medesima difficoltà della sintesi, in vista della quale si costituisce propriamente la critica, e per l'altro perché si andrebbe contro l'unità del piano se si pretendesse dare, sotto la responsabilità della compiutezza, una tale analisi e derivazione, a cui non siamo punto obbligati dai nostri progetti. Questa compiutezza, cosi nell'analisi come nella derivazione da quei concetti a priori che dovremo fornire più avanti, costituisce una facile aggiun-ta, una volta che quei concetti siano a disposizione come principi specifici della sintesi e nulla faccia difetto in vista di questo scopo essenziale. Rientra pertanto nella critica della ragion pura tutto ciò che costituisce la filosofia trascendentale; tale critica è dunque l'idea perfetta della filosofia trascen-dentale, senza essere tuttavia questa scienza stessa, perché spinge la sua analisi solo fin là dove è richiesto da una valutazione esauriente della conoscenza sintetica a priori. Ciò a cui principalmente si mira nella suddivisione di questa scienza è la radicale esclusione di ogni concetto che contenga in sé qualcosa di empirico, ossia la completa purezza della conoscenza a priori. Quindi, pur essendo i supremi principi della moralità - ed i relativi concetti fondamentali - conoscenze a priori, non rientrano tuttavia nella filosofia trascendentale perché essi, pur non ponendo alla base dei loro precetti morali i concetti del piacere e del dolore, dei desideri e delle tendenze, ecc., che hanno tutti un'origine empirica, non possono tuttavia, nella costruzione del sistema della moralità, non farli entrare nel concetto del dovere o come un ostacolo da superare o come uno stimolo non trasformabile in motivo 38 Pertanto la filosofia trascendentale è una sapienza cosmica della ragion pura sem- No plicemente speculativa. Infatti tutto ciò che è pratico, per il fatto di contenere motivi, si riconduce a sentimenti, i quali appartengono alle sorgenti empiriche della conoscenza. Ma se si vuol dar luogo alla suddivisione di questa scienza dal punto di vista generale di un sistema, detta scienza - che ci accingiamo ad esporre — deve allora contenere prima di tutto una dottrina degli elementi e poi una dottrina del metodo della ragion pura 39 . Ognuna di queste parti principali subirà ulteriori suddivisioni, i cui fondamenti non si possono qui ancora esporre. In sede di introduzione o di avvertenza preliminare, pare necessario limitarsi ad osservare che esistono due tronchi dell'umana conoscenza, provenienti forse da una comune radice, a noi sonosa, piecisamente sensibili ed elsa; edia, te laurima ai oscica . Ora, in quanto la sensibilità deve contenere rappresentazioni a priori, che costituiscono la condizione a cui gli oggetti ci sono dati, essa deve appartenere alla filosofia trascendentale. La dottrina trascendentale della sensibilità deve rientrare nella prima parte della scienza degli elementi, in quanto le condizioni sotto cui gli oggetti dell'umana conoscenza sono dati precedono quelle sotto le quali i medesimi oggetti sono pensati.