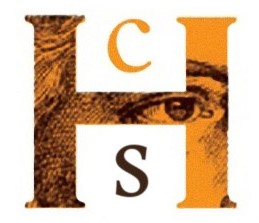Torna indietro
Opere fondamentali classe IV
La critica della ragion pura
La rivoluzione copernicana
La prima delle tre critiche kantiane (1781) è dedicata al problema della conoscenza. Qui Kant riflette sui fondamenti, sui limiti e sulle condizioni di validità della conoscenza cercando la risposta a quattro quesiti:
- Come è possibile la matematica pura?
- Come è possibile la fisica pura?
- Come è possibile la metafisica in quanto disposizione naturale?
- Come è possibile la metafisica come scienza? L'obiettivo di Kant, perseguito attraverso un serrato confronto con le teorie gnoseologiche del razionalismo e dell'empirismo, è dunque scoprire la natura della vera conoscenza, cioè della scienza, distinguendola dalla metafisica.
Che cosa significa conoscere?
Conoscere, secondo Kant, equivale a giudicare, cioè a connettere un soggetto e un predicato.
Come vengono chiamati da Kant i giudizi tipici della tradizione filosofica del razionalismo? E quelli propri della tradizione filosofica dell'empirismo?
La conoscenza si esprime attraverso dei giudizi, così chiamati perché costituiti da un soggetto di cui si dice qualche cosa nel predicato: per esempio, "la Terra è rotonda". I giudizi dei razionalisti, chiamati analitici a priori, e degli empiristi, chiamati sintetici a posteriori, sono frutto di convinzioni opposte, entrambe però inaccettabili agli occhi di Kant.
Quali sono, secondo Kant, punti di forza e limiti dei due tipi di giudizio?
I giudizi analitici a priori sono universali e necessari in quanto indipendenti dall'esperienza, ma infecondi; i giudizi sintetici a posteriori sono fecondi ma non universali e necessari in quanto formulati su base empirica.
In che cosa consiste la "rivoluzione copernicana" attuata da Kant in ambito gnoseologico?
La "rivoluzione copernicana" consiste nel fondare la conoscenza sulle strutture conoscitive proprie dell'uomo. Secondo Kant, infatti, la conoscenza è il risultato dell'unione di una materia, che deriva dall'esperienza ed è dunque a posteriori, e di una forma, che è posta dal soggetto conoscente ed è dunque a priori rispetto all'esperienza. Così, come Copernico aveva posto al centro dell'universo il Sole e non più la Terra, egli pone a fondamento della conoscenza il soggetto conoscente e non l'oggetto conosciuto.
Qual è l'oggetto della conoscenza dell'uomo?
È il fenomeno, "ciò che appare", cioè il risultato dell'unione di materia e forma. Il fenomeno è infatti il risultato della sintesi dei dati empirici e delle strutture conoscitive proprie dell'uomo, chiamate da Kant forme pure a priori. La conoscenza, dunque, ha certamente origine dall'esperienza, ma non per questo deriva tutta dall'esperienza, perché l'esperienza è preceduta dalle strutture della mente umana.
Secondo Kant, esistono anche i giudizi sintetici a priori; fecondi perché formulati a partire dall'esperienza, ma anche universali e necessari perché fondati sulle forme pure a priori, cioè sulle modalità conoscitive del soggetto. Sui giudizi sintetici a priori si fonda la scienza. Individuando i giudizi sintetici a priori Kant mostra che la conoscenza deriva dall'esperienza, ma che non può essere del tutto ridotta a essa.
Si riferisce a ciò che precede ogni conoscenza e la rende possibile; "trascendentale" è dunque lo studio filosofico delle forme pure a priori.
Tre sono le facoltà conoscitive della ragione intesa in senso lato:
- la sensibilità, cioè la facoltà che attraverso i sensi intuisce gli oggetti e li rappresenta attraverso spazio e tempo;
- l'intelletto, cioè la facoltà con cui pensiamo gli oggetti;
- la ragione (in senso stretto), cioè la facoltà con cui tendiamo a spiegare globalmente la realtà attraverso le idee di anima, mondo e Dio.
La struttura della dottrina degli elementi riflette l'articolazione delle facoltà conoscitive ed è quindi divisa in tre parti:
- l'estetica trascendentale, che studia le forme pure a priori della sensibilità;
- la logica trascendentale, a sua volta articolata in:
- analitica trascendentale, che studia le forme pure a priori dell'intelletto;
- dialettica trascendentale, che studia le forme pure a priori della ragione.
L'estetica trascendentale
La matematica, che è possibile ed è una scienza propria in quanto si fonda sulle intuizioni pure a priori di spazio (geometria) e tempo (aritmetica). L'aritmetica presuppone infatti l'idea di "successione ordinata" (che si sviluppa quindi nel tempo) di numeri. Allo stesso modo è solo il nostro modo d'intendere lo spazio a rendere possibile la geometria.
L'analitica trascendentale
Quali sono le forme pure a priori dell'intelletto?
Le forme pure a priori dell'intelletto sono i concetti puri o categorie, cioè funzioni con cui la mente ordina o unifica diverse rappresentazioni in una rappresentazione comune.
Che cosa sono i concetti puri?
I concetti puri costituiscono i modi con cui la mente umana organizza l'esperienza e (a differenza dei concetti empirici) sono a priori rispetto all'esperienza.
Che differenza c'è tra intuizione e concetto?
Mentre l'intuizione è la conoscenza immediata di un singolo oggetto, il concetto è una conoscenza mediata di più oggetti che nasce quando il pensiero coglie il tratto che li accomuna. I concetti sono frutto dell'attività della mente, cioè funzioni con cui l'intelletto ordina o unifica diverse rappresentazioni in una rappresentazione comune.
Che relazione c'è tra sensibilità e intelletto?
Per quanto non esistano separatamente, la sensibilità, come facoltà delle intuizioni, e l'intelletto, come facoltà dei concetti, non possono scambiarsi le funzioni, né l'una può stare senza l'altro: infatti i concetti senza intuizioni sono vuoti e le intuizioni senza concetti sono cieche.
Che differenza c'è tra le categorie kantiane e quelle aristoteliche?
Le categorie kantiane, a differenza di quelle aristoteliche, non hanno alcun valore ontologico ma soltanto un valore gnoseologico. Le categorie kantiane sono così ricavate da un principio che possiamo così riassumere: poiché pensare equivale a giudicare, necessariamente le categorie devono corrispondere alle tipologie di giudizio che la mente può esprimere.
Quante sono le categorie?
Le categorie sono dodici e, sulla base del presupposto che pensare equivale a giudicare, sono ricavate dalla tavola dei giudizi. Le tipologie di giudizio sono quattro: quantità, qualità, relazione, modalità; ognuna di esse contiene al proprio interno tre giudizi, per un totale di dodici giudizi, cui corrispondono appunto dodici categorie. Tra queste due sono quelle fondamentali: la sostanza e la causalità.
Quale scienza si fonda sulle categorie?
La fisica, che è una scienza proprio in quanto si fonda sulle categorie: affinché l'esperienza sia possibile, infatti, il molteplice dell'intuizione deve essere ricondotto all'unità del concetto, che stabilisce che certe rappresentazioni sono costantemente connesse tra loro, e non soltanto qui e ora per un certo soggetto.
Che cos'è la deduzione trascendentale delle categorie?
La deduzione trascendentale delle categorie è la dimostrazione della legittimità dell'uso delle categorie in riferimento agli oggetti dell'esperienza (qui il termine deduzione è utilizzato da Kant nel suo significato giuridico).
Come si giustifica l'applicazione delle categorie agli oggetti d'esperienza?
L'uso delle categorie è legittimo perché, come le cose per essere intuite devono sottostare al modo con cui la sensibilità costruisce il mondo dell'esperienza attraverso spazio e tempo, così le cose per essere pensate devono sottostare al modo con cui l'intelletto riflette sul mondo dell'esperienza attraverso le categorie. L'applicazione delle categorie agli oggetti d'esperienza è dunque del tutto legittima perché sono le stesse categorie a rendere possibile l'esperienza.
Che cos'è l'Io penso?
L'Io penso (o appercezione trascendentale) è il centro di unificazione delle categorie. Esso è l'autocoscienza o coscienza generale che costituisce il supremo principio formale di unificazione: senza la funzione dell'Io penso si avrebbe soltanto un susseguirsi di rappresentazioni estranee le une alle altre, mentre affinché la conoscenza sia possibile le rappresentazioni devono essere connesse in una coscienza generale, valida cioè per qualsiasi soggetto, che nelle stesse circostanze dovrà collegare le rappresentazioni nello stesso modo. L'Io penso, dunque, costituisce il fondamento ultimo della legittimità dell'uso delle categorie.
Perché l'Io penso è definito da Kant come legislatore della natura?
L'Io penso è definito come legislatore della natura poiché la natura è conoscibile soltanto nella misura in cui obbedisce all'Io penso: l'intelletto, infatti, non ricava le leggi dalla natura, ma le prescrive a essa.
Che differenza c'è tra fenomeno e noumeno?
Il fenomeno è la cosa per me, cioè il risultato dell'applicazione delle forme pure a priori all'oggetto d'esperienza, mentre il noumeno è la cosa in sé, così com'è veramente, una realtà che però può essere solo pensata ma non conosciuta. Kant non mette in dubbio l'esistenza degli oggetti fuori di noi, ma sostiene solo che è impossibile affermare qualcosa intorno agli oggetti come sono "in sé": tutto ciò che conosciamo degli oggetti è soltanto l'aspetto fenomenico. La conoscenza umana è dunque limitata.
Che cosa sono gli schemi trascendentali?
Gli schemi trascendentali, prodotti dalla facoltà dell'immaginazione produttiva, sono il mezzo con cui i concetti puri sono applicati agli oggetti dati dall'esperienza. Essi si fondano sull'intuizione pura del tempo, che è la condizione formale a priori di tutti i fenomeni. Attraverso la mediazione degli schemi, le categorie assumono la forma di leggi generali dell'esperienza e dunque anche di leggi generali della natura. L'insieme di queste leggi costituisce il sistema dei principi dell'intelletto puro: gli assiomi dell'intuizione, le anticipazioni della percezione, le analogie dell'esperienza (che corrispondono alle tre leggi del moto enunciate da Newton) e i postulati del pensiero empirico in generale.
La dialettica trascendentale
Le tre forme pure a priori della ragione sono le tre idee trascendentali: l'idea di anima, l'idea di mondo e l'idea di Dio.
Che cosa mostrano le idee della ragione a proposito della metafisica?
Tali idee mostrano che la metafisica, pur essendo una naturale inclinazione dell'uomo che aspira all'assoluto, non è una scienza ma una conoscenza fallace, palesando come il tentativo della ragione di oltrepassare i limiti dell'esperienza sia fallimentare.
Che cos'è l'idea di anima?
L'idea di anima è l'idea della totalità dei fenomeni interni.
Da dove nasce l'idea di anima?
L'idea di anima è il risultato di un paralogismo, cioè di un ragionamento fallace, che consiste nell'applicare la categoria di sostanza all'Io penso. In questo modo l'attività unificatrice del soggetto (che rende possibile l'esperienza ma che non può a sua volta essere oggetto di esperienza) viene trasformata in una realtà esistente chiamata anima.
Che cos'è l'idea di mondo?
L'idea di mondo è l'idea della totalità dei fenomeni esterni.
Che cosa sono le antinomie?
Le antinomie sono le insolubili contraddizioni in cui cade la ragione nel momento in cui pretende di far uso della nozione di mondo. La strutturale insolubilità delle antinomie dipende dal fatto che entrambe le affermazioni di cui si compongono (tesi e antitesi) pretendono di riferirsi al mondo inteso come un tutto, che in quanto tale non è oggetto d'esperienza.
Quali sono le antinomie?
Kant individua quattro antinomie, formulate per rispondere a quattro domande, inevitabili ma destinate a rimanere senza risposta:
- Il mondo ha limiti nel tempo e nello spazio o è infinito?
- Esiste o no qualcosa di assolutamente semplice?
- È possibile la libertà o tutto è causalmente determinato?
- Esiste o no una causa ultima e necessaria?
- Nel caso delle prime due antinomie (matematiche) sono da considerare false sia la tesi sia l'antitesi; nel caso delle ultime due antinomie (dinamiche) è invece possibile considerare vere sia la tesi sia l'antitesi, a patto di riferire la tesi al mondo noumenico e l'antitesi al mondo fenomenico.
Che cos'è l'idea di Dio?
L'idea di Dio è l'idea della totalità assoluta.
Come valuta Kant le tradizionali prove dell'esistenza di Dio?
Le tradizionali prove dell'esistenza di Dio sono, secondo Kant, tutte fallimentari:
- la prova ontologica, che pretende di ricavare l'esistenza da un concetto, passa indebitamente dal piano logico al piano ontologico;
- la prova cosmologica, che pone Dio come causa incausata, usa in modo illegittimo la categoria di causa fuori dall'ambito fenomenico;
Qual è l'unica funzione legittima delle idee della ragione?
Le idee della ragione non possono avere alcun uso costituivo per la conoscenza, in quanto è illegittimo fare affermazioni a priori intorno a oggetti che non possono essere dati in alcuna esperienza possibile. Possono però svolgere una funzione regolativa, che consiste nel dare unità ai concetti dell'intelletto come se dipendessero da un principio unitario, e conferire cisì alla conoscenza la masssima unità e la massima estensione possibili.
1 La rivoluzione copernicana
Il problema della conoscenza: quattro quesiti
La Critica della ragion pura, la prima opera del periodo critico, è dedicata al problema della conoscenza. Pubblicata in una prima edizione nel 1781, fu seguita nel 1783 da una versione più breve e semplice intitolata Prolegomeni ad ogni futura metafisica che voglia presentarsi come scienza. Nel 1787 apparve infine la seconda edizione della Critica della ragion pura con importanti rimaneggiamenti.
Già nel titolo traspare l'obiettivo di Kant: criticare, nel senso di giudicare, la ragione e le sue pretese conoscitive nel momento in cui è "pura", cioè non mescolata a nulla di empirico. Nella prefazione alla prima edizione dell'opera, Kant afferma infatti che la ragione umana ha una naturale tendenza a occuparsi anche di problemi che vanno al di là delle sue reali possibilità conoscitive. Ma se così è, tutte le nostre certezze vanno messe in discussione a incominciare da quelle più distanti dall'esperienza, da cui ogni conoscenza dovrebbe cominciare. Ecco allora che diventa necessario istituire un tribunale della ragione e questo non può essere che la critica della ragion pura, nei due sensi, soggettivo e oggettivo, del genitivo. Tocca infatti alla ragione stessa il compito di stabilire i propri limiti, e quindi la ragione si ritrova a essere al tempo stesso imputata e giudice.
L'opera si configura come un'analisi critica dei fondamenti e delle condizioni di validità della conoscenza negli ambiti della scienza e della metafisica; scrive Kant:
poiché queste scienze [la matematica e la fisica] sono effettivamente date, conviene di certo domandarsi come siano possibili; infatti che esse siano possibili è dimostrato dalla loro realtà. Quanto alla metafisica, il suo cattivo andamento fino a oggi [...] fa dubitare chiunque, a ragione, della sua possibilità. Tuttavia, anche questa specie di conoscenza deve in certo senso esser considerata come data, e la metafisica, anche se non come scienza, è tuttavia reale come disposizione naturale.La natura della vera conoscenza coincide con la scienza
Kant non dubita affatto della scientificità della matematica e della fisica, attestata dai fatti: la questione è, piuttosto, mostrare non che ma come esse siano possibili in quanto scienze. Diverso è il caso della metafisica: se è senza dubbio reale come disposizione naturale, è invece assolutamente controversa la sua possibilità di costituirsi come scienza. E da Kant, come vedremo, tale possibilità è totalmente negata.
In sintesi dunque, il problema della conoscenza si articola nei seguenti quattro quesiti formulati nell'introduzione dell'opera.
- "Com'è possibile la matematica pura?"
- "Com'è possibile la fisica pura?"
- "Com'è possibile la metafisica in quanto disposizione naturale?"
- "Com'è possibile la metafisica come scienza?"
Come si vede, dunque, l'obiettivo che Kant si pone con la Critica della ragion pura è decisamente ambizioso: scoprire la natura della vera conoscenza, che coincide con la scienza, così da sconfiggere le impostazioni errate che si scontrano nel dibattito culturale del tempo:
- il dogmatismo di chi fa ricorso in modo dispotico a «principi che oltrepassano ogni possibile esperienza»;
- lo scetticismo di chi opponendosi al dogmatismo nega ogni possibile conoscenza scientifica;
- l'indifferentismo di chi finge di non essere interessato alla conoscenza scientifica, mentre «il suo oggetto non può mai essere indifferente alla natura umana».
Kant contro i razionalisti e gli empiristi
Dal momento che la conoscenza si esprime attraverso i giudizi, Kant avvia la sua riflessione con il loro esame. Un giudizio è una proposizione composta da un soggetto e un predicato, dove il predicato dice qualcosa del soggetto: per esempio, "la Terra è rotonda".
Kant, sulla scia di Leibniz e Hume, distingue immediatamente due tipi di giudizi, che definisce giudizi analitici a priori e giudizi sintetici a posteriori.
Nei primi la presenza del predicato non aggiunge nulla al soggetto perché è già implicita, sebbene confusamente, nel soggetto: per esempio nel giudizio "i corpi sono estesi", il concetto di estensione è già implicito nel concetto di corpo (i corpi sono estesi per definizione).
Questi giudizi, fondati soltanto sul principio di non contraddizione, sono a priori, cioè non comportano alcun riferimento all'esperienza, in quanto consistono in una semplice "analisi" del soggetto. Sono pertanto universali e necessari ma, in quanto mere tautologie, sono infecondi, cioè non producono nuova conoscenza.
Per contro, nei giudizi sintetici a posteriori il predicato aggiunge, con un'operazione di sintesi, qualcosa di nuovo al soggetto: nel giudizio "i corpi sono pesanti", il concetto di pesante non è affatto implicito nel concetto di corpo, ma è un dato nuovo conosciuto dopo aver fatto esperienza di diversi corpi. Tali giudizi sono allora a posteriori, perché sono formulati a partire dall'esperienza, e pertanto non possono essere né universali né necessari dal momento che, come Hume insegna, l'esperienza non è in grado di garantire universalità e necessità. Sono però fecondi perché capaci di incrementare la conoscenza.
Queste due categorie di giudizi esprimono le diverse concezioni gnoseologiche del razionalismo e dell'empirismo. Il primo ammette l'esistenza di idee innate, cioè di contenuti della mente indipendenti dall'esperienza su cui fondare la conoscenza: accetta cioè l'esistenza di conoscenze a priori. Il secondo sostiene invece che la conoscenza è sempre e solo frutto dell'esperienza: di conseguenza può essere solo a posteriori, successiva cioè al rapporto con il mondo esterno. Adottando il primo approccio si garantisce la possibilità di una conoscenza universale e necessaria, ma si rinuncia alla possibilità di incrementare la conoscenza; adottando il secondo, specularmente, si rinuncia alla possibilità di una conoscenza universale e necessaria, ma si garantisce la possibilità di incrementare la conoscenza.
Respinte come inadeguate le concezioni gnoseologiche tradizionali, il razionalismo perché misconosce il ruolo dell'esperienza, e l'empirismo perché conduce inevitabilmente allo scetticismo, a Kant non rimane che cercare un modo alternativo di giustificare la possibilità di una conoscenza che sia in grado di ampliare il nostro sapere e sia, allo stesso tempo, oggettivamente valida.
Kant distingue due diversi elementi che entrano in gioco nella conoscenza umana, la materia e la forma:
- la materia deriva dall'esperienza ed è data dalle singole sensazioni o modificazioni che il soggetto subisce, ed è quindi a posteriori;
- la forma invece non è prodotta dalle sensazioni, ma è posta dal soggetto conoscente; è dunque a priori rispetto all'esperienza, ed è anzi la condizione di possibilità dell'esperienza stessa.
Secondo Kant la forma che viene posta dal soggetto riveste un ruolo fondamentale nella conoscenza. Egli stesso definisce questa nuova concezione gnoseologica una "rivoluzione copernicana": come infatti Copernico aveva messo al centro dell'universo il Sole, e non la Terra come tradizionalmente si riteneva, così Kant pone a fondamento della conoscenza il soggetto che conosce e non l'oggetto conosciuto. Detto altrimenti, non è la nostra struttura mentale (Sole) che si adatta alla natura (Terra), ma è la natura (Terra) che si adatta alla nostra struttura mentale (Sole). La conoscenza si fonda, dunque, sulle strutture conoscitive proprie dell'uomo.
Il risultato dell'unione di materia e forma è il fenomeno, "ciò che appare":
Nel fenomeno io chiamo materia ciò che corrisponde a una sensazione; ciò per cui il molteplice del fenomeno possa essere ordinato in determinati rapporti chiamo forma del fenomeno. Poiché quello in cui soltanto le forme si ordinano non può essere di nuovo sensazione, così la materia di ogni fenomeno deve essere bensi data a posteriori, ma la forma di esso deve trovarsi a priori nello spirito. (Critica della ragion pratica)Il fenomeno si configura, quindi, come l'unico oggetto possibile della conoscenza umana. Ciò non significa che non esistano le cose reali al di fuori della mente, ma che – come accadeva al re Mida che trasformava tutto in oro – quando la mente umana entra in contatto con le cose le trasforma in qualcos'altro. Come chi, per esempio, vede il mondo tutto caratterizzato da sfumature rosse perché porta degli occhiali con lenti rosse, così noi costruiamo il mondo dell'esperienza filtrandolo attraverso le nostre strutture conoscitive, chiamate da Kant forme pure a priori. Sono proprio le forme pure a priori, cioè le modalità conoscitive presenti nel soggetto, che rendono possibile la conoscenza: il fondamento del nostro modo di conoscere gli oggetti è allora a priori, cioè si trova nel soggetto stesso che sente e pensa. Detto altrimenti, per Kant la conoscenza ha certamente origine dall'esperienza: non c'è dubbio alcuno infatti che la nostra conoscenza incomincia con l'esperienza, perché in essa trova l'occasione del suo sorgere. Non per questo tuttavia la conoscenza deriva tutta dall'esperienza, perché l'esperienza è preceduta dalle strutture della mente umana. Per comprendere dunque il significato della conoscenza bisogna partire dall'uomo e non dalle cose, poiché le cose per essere conosciute devono essere pensate in un certo modo.
I giudizi sintetici a prioriSe noi, dunque, poniamo al centro del rapporto conoscitivo il soggetto conoscente (Sole) e attorno a esso facciamo ruotare l'oggetto conosciuto (Terra), diventa possibile superare sia il dogmatismo dei razionalisti sia lo scetticismo degli empiristi e giustificare l'esistenza di una conoscenza che, pur avendo origine nell'esperienza, sia anche universale e necessaria. Così, accanto ai giudizi analitici a priori e ai giudizi sintetici a posteriori, Kant individua i giudizi sintetici a priori: fecondi, universali e necessari.
Per Kant i giudizi sintetici a priori sono i pilastri su cui si fonda la scienza; ad esempio, il giudizio "7 + 5 = 12" è un giudizio a priori, e quindi universale e necessario, in quanto è valido non soltanto per 7 e 5 punti oppure 7 e 5 uomini, ma è sempre e immancabilmente valido; è inoltre anche un giudizio sintetico dal momento che la somma 12 non è compresa nel soggetto né da esso ricavabile per via di sola analisi, ma costituisce qualcosa di nuovo rispetto al soggetto.
Questi giudizi, afferma Kant, si fondano sulle forme pure a priori, cioè sulle modalità conoscitive proprie del soggetto.