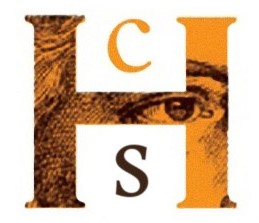Lo Zarathustra e la volontà di potenza
I contenuti fondamentali dell'ultima fase del pensiero di Nietzsche, a partire cioè da Così parlò Zarathustra, ruotano attorno alle concezioni dell'eterno ritorno, della morte di Dio e del superuomo. Di qui, si giunge infine all'estremo tentativo nietzschiano di elaborare un'opera sistematica che doveva recare il titolo La volontà di potenza e che doveva essere centrata sul programma di una trasvalutazione di tutti i valori.
La difficoltà di interpretare in modo univoco il pensiero di Nietzsche si accentua a partire da Così parlò Zarathustra. Quest'opera introduce nella filosofia nietzschiana alcuni rilevanti mutamenti, che riguardano sia il piano dei contenuti, sia quello dello stile. Sul piano dei contenuti, diventano ora centrali i temi dell'eterno ritorno e del superuomo, che implicano l'idea di una trasformazione radicale dell'umanità e della civiltà – una trasformazione di cui Nietzsche si sente annunciatore e profeta. A questa intonazione profetica sono legati i mutamenti sul piano dello stile, che non è più quello del saggio, del trattato o della raccolta di aforismi, ma è quello di una sorta di poema in prosa, a metà tra filosofia e poesia, costruito sul modello della struttura in versetti del Nuovo Testamento. Si tratta dunque di un filosofare che, nel tentativo di spingersi oltre i limiti del pensiero metafisico, si muove più nella dimensione dell'immagine e dell'allegoria che in quella del concetto inteso in senso tradizionale 1.
Lo sfondo su cui si stagliano i temi caratteristici dell'ultima fase del pensiero di Nietzsche è quello del nichilismo. Nietzsche distingue due forme di nichilismo: il nichilismo passivo e il nichilismo attivo. Il nichilismo passivo coincide con l'atteggiamento di chi, di fronte alla crisi dei valori, alla fine della fede in un mondo trascendente e alla relativa perdita di senso del mondo, reagisce deprimendo questa condizione, vivendola con dolore e con risentimento nei confronti della vita. Nichilismo attivo è invece quello di chi, in questa situazione, contribuisce attivamente alla distruzione dei valori, preparando in tal modo l'avvento di una nuova umanità, capace di vivere nella «fedeltà alla terra» e di sopportare l'assenza di un orizzonte ultimo di senso 2.
Per l'emergere di questa idea di una nuova umanità, in grado di «dire di sì alla vita» in quanto libero gioco creativo, la filosofia di Nietzsche è ora dominata dall'immagine del "meriggio": il mezzogiorno, l'ora senz'ombra, è il momento in cui incomincia l'insegnamento di Zarathustra. L'immagine del mezzogiorno indica talvolta, come nella Genealogia della morale, l'ora di una «grande decisione», in cui giunge «l'uomo redentore, l'uomo del grande amore e disprezzo, lo spirito creatore», e talialtra, come nello Zarathustra, un momento di maturazione in cui il mondo diventa perfetto, «rotondo» e «maturo». Nell'immagine del meriggio si celano dunque le tensioni del pensiero dell'ultimo Nietzsche, in particolare la contraddizione tra il senso di perfezione e immobilità cui aspira il personaggio di Zarathustra (alter ego dello stesso Nietzsche) e la necessità di confrontarsi con il problema della decisione; da una parte, la compiutezza meridiana della circolarità del ritorno è prodotta dalla decisione del superuomo; dall'altra, questa dimensione decisionale dinamica e attivistica trova un limite nella tendenza alla dissoluzione della soggettività che sembra implicita nell'idea del ritorno.
Dire di sì alla vita
L'idea del superuomo, che rappresenta per certi aspetti uno sviluppo della figura dello “spirito libero”, si trova al centro della prima parte dello Zarathustra. La caratteristica fondamentale del superuomo è la sua capacità di «dire di sì alla vita», accettandola con gioia e fiducia in tutti i suoi aspetti, anche in quelli negativi, oscuri e dolorosi, e volerne la ripetizione eterna. In questo senso, il superuomo esprime un atteggiamento tragico e dionisiaco nei confronti della vita.
La morte di Dio e la fedeltà alla terra
Il presupposto che rende possibile la nascita del superuomo è la morte di Dio. La fine degli ideali sovrumani, dei mondi trascendenti della metafisica, della teologia e della morale, non rappresenta solo il rischio di un impoverimento e di un inaridimento della vita, ma anche l’occasione positiva per la nascita di un’umanità che comprenda se stessa non più in rapporto a un Dio trascendente, ma a partire dall’orizzonte del mondo, e che sappia creare liberamente se stessa e i propri valori. Il superuomo è l’uomo capace di sopportare la morte di Dio e di vivere la vita terrena come unica e ultima realtà, nella consapevolezza tragica dell’assenza di mondi ultraterreni e di ogni prospettiva di redenzione.
Il superuomo nasce dunque dalla negazione e dal superamento dell’uomo così come si è configurato nell’intero sviluppo della civiltà occidentale. Affinché nasca il superuomo, l’uomo deve elevarsi al di sopra di sé, deve “tramontare”. «La grandezza dell’uomo – scrive Nietzsche – è di essere un ponte e non uno scopo: nell’uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto».
Per descrivere questo auto-superamento dell’uomo, Nietzsche utilizza un’immagine – «l’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo» – che nel passato è stata fraintesa come espressione di una forma di evoluzionismo naturalistico che vedrebbe nel superuomo una sorta di essere superiore determinato da un’evoluzione di carattere biologico. Per evitare fraintendimenti di questo genere, che hanno portato tra l’altro gli ideologi del nazismo a considerare la figura del superuomo come un’anticipazione della dottrina del primato della razza ariana, il filosofo Gianni Vattimo ha proposto di tradurre il tedesco Übermensch con l’espressione “oltreuomo”.
Egli ha voluto così sottolineare come il superuomo, in quanto rinvia all’idea di un’autotrascendenza dell’umanità, rappresenti una rottura radicale e un’“ulteriorità” rispetto a una concezione dell’umanità come soggetto di potenza e di forza.
Il superuomo, che viene annunciato da Nietzsche come una speranza in grado di ricomporre la realtà frantumata dell’uomo del presente, si trova al proprio concetto complementare nell’ultimo uomo. Questi è l’uomo del nichilismo passivo, privo di slancio creativo e progettuale. Se il superuomo è l’uomo capace di “scagliare la propria freccia anelante al di là dell’uomo”, di “partorire una stella danzante” dal proprio caos interiore, l’ultimo uomo è viceversa “l’uomo più spregevole, quelli che non sa disprezzare se stesso”, che “rimpicciolisce tutto”, incapace di creare e superare se stesso. «Una goffagginezza per il giorno e una vogliuzza per la notte, salva restando la salute»: così viene sarcasticamente descritto da Nietzsche l’ideale di vita dell’ultimo uomo, vale a dire dell’uomo moderno.
In opposizione all’ultimo uomo, il superuomo è “l’uomo del grande amore” e “del grande disprezzo”, l’uomo che, decidendo di vivere secondo la legge dell’eterno ritorno, può produrre l’uscita dell’umanità dall’orizzonte del nichilismo e dalla condizione di dispersione e frammentazione in cui essa attualmente versa.
Nelle pagine autobiografiche di Ecce homo Nietzsche ha caratterizzato il pensiero dell’eterno ritorno come “la suprema formula di affermazione che si possa raggiungere”, individuandolo come la dottrina fondamentale dello Zarathustra. Esposta per la prima volta, come abbiamo già visto, nella Gaia scienza (aforisma 341), questa dottrina svolge un ruolo centrale nella terza parte dello Zarathustra e, segnatamente, nei tre discorsi intitolati Della redenzione, La visione e l’enigma, Il convalescente. Per il suo carattere allegorico e immaginifico.