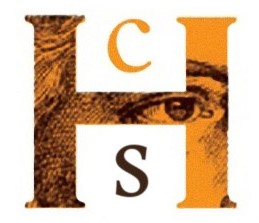Torna indietro
Platone
Platone indaga con la ragione il significato dell'essere
Proseguendo la ricerca socratica, Platone affronta argomenti che hanno suscitato appassionati dibattiti in tutte le epoche: che cos'è il bene? Che cos'è la bellezza? Che cos'è l'amore?
- Platone fu l'inventore delle idee intese come forme immateriali in cui si articola l'essere.
- Platone fu il padre dell'utopismo: la Repubblica di Platone è infatti la prima utopia della storia, il primo esempio di Stato ideale.
- Platone s'interrogò anche su che cosa sia la natura e descrisse la bellezza matematica del mondo.
- Platone infine per meglio chiarire il suo ragionamento filosofico ricorse ai miti.
Platone apparteneva a una delle più importanti famiglie aristocratiche di Atene
Platone nacque ad Atene tra il 428 e il 427 a.C. mentre infuriava la guerra tra Atene e Sparta. Era cresciuto vedendo gli effetti devastanti della crisi morale e politica in cui versava la Grecia.
La famiglia di Platone apparteneva all'élite dell'aristocrazia ateniese. Il padre vantava tra i suoi antenati addirittura il mitico re di Atene, Codro. La madre discendeva da Solone.
Il vero nome di Platone era Aristocle. Il soprannome di Platone significa "ampio", forse in riferimento alla sua forza fisica, o alla vastità della sua fronte, o all'ampiezza del suo stile.
L'incontro con Socrate favorì in Platone il sorgere della riflessione politica
Durante la giovinezza, tutto faceva pensare che la politica attiva sarebbe stata il destino di Platone. Ciò non accadde per due ragioni:
- l'incontro con Socrate, avvenuto quando Platone aveva circa vent'anni, che favorì in Platone il sorgere di una riflessione teorica sulla politica, che lo allontanò da quella attiva.
- il disgusto per la politica ateniese, culminata nella condanna a morte di Socrate, quando Platone aveva 28 anni. In quanto amico e discepolo di Socrate, Platone preferì lasciare Atene.
Platone tentò di riformare la vita politica di Siracusa, ma senza successo
Secondo Platone, gli uomini si sarebbero liberati dal male se fossero giunti al potere i filosofi; conseguentemente, cercò di trasformare dei governanti in filosofi durante i suoi soggiorni a Siracusa. Inizialmente cercò di persuadere delle sue idee riformatrici Dionigi il Vecchio, ma senza risultato. L'amicizia di Platone col potente Dione attirò i sospetti di Dionigi: questi consegnò Platone a un ambasciatore spartano che lo vendette come schiavo. Per fortuna un amico di Socrate lo riscattò.
Al successo dell'Accademia ad Atene corrisposero solo altri fallimenti a Siracusa
Tornato ad Atene, Platone fondò l'Accademia, la sua scuola: era caratterizzata dalla vita in comune del maestro con i suoi discepoli e Platone vi insegnò per circa vent'anni.
Nel 367 si recò di nuovo a Siracusa dove era salito al potere Dionigi il Giovane: nonostante le speranze di far attuare al nuovo tiranno le riforme proposte da Platone, questi e Dione vennero cacciati dalla città. Nel 361 Platone fu invitato a Siracusa dallo stesso Dionigi il Giovane, che si rivelò però troppo presuntuoso per accettare i consigli di Platone.
Solo un anno dopo Platone poté definitivamente ritornare ad Atene da dove non si allontanò più. Morì nel 347 all'età di 80 o 81 anni.
LE OPERE E LA SCELTA DELLA FORMA DEL DIALOGO
Platone è il primo filosofo dell'antichità di cui ci sono giunte tutte le opere
Platone iniziò a scrivere a circa trent'anni. I suoi scritti comprendono 34 dialoghi, l'Apologia di Socrate e 13 lettere.
Gli studiosi sono riusciti a ricostruire un ordine cronologico plausibile dei dialoghi. Abbiamo così: i dialoghi giovanili, i dialoghi della maturità e i dialoghi della vecchiaia. Sotto il nome di Platone sono giunte anche tredici lettere: tra di esse la Lettera VII contiene importanti notizie sulla vita del filosofo, soprattutto riguardo agli anni giovanili e al suo interesse per la vita politica.
Per Platone la parola scritta non era strumento adeguato per trasmettere la conoscenza filosofica
Socrate non scrisse nulla, perché, come nel Fedro, ci sono tre limiti della scrittura:
1. esporre una dottrina filosofica in uno scritto può illudere circa la facilità di apprendere il sapere, e il libro stesso può cadere nelle mani di gente impreparata;
2. una volta scritta, la dottrina non è in grado di rispondere alle obiezioni o di offrire chiarimenti, come solo l'autore nel dialogo diretto potrebbe fare;
3. il dialogo spinge a utilizzare la memoria, lo scritto induce alla pigrizia e alla dimenticanza.
Tuttavia Platone non rinunciò alla scrittura: nella sua intenzione gli scritti non dovevano trasmettere il suo pensiero, ma quello di stimolare la ricerca filosofica. Per questo scelse la forma del dialogo, secondo il modello socratico della discussione.
L'uso del mito in Platone
Platone inventò dei miti e li inserì – a differenza dei miti tradizionali – in un discorso razionale (lógos). Questi racconti fantastici svolgono due principali funzioni.
1. Alcuni vengono utilizzati per illustrare in maniera intuitiva un discorso: hanno una funzione divulgativa, come un efficace espediente didattico.
2. Altri svolgono invece una funzione allusiva: rimandano cioè a una dimensione che va oltre le capacità dell'indagine filosofica. La filosofia infatti si trova sovente ai confini del pensabile. Oltre questi confini, la ragione non trova più parole ed è costretta a procedere per immagini.
SOCRATE E LA POLEMICA CON I SOFISTI
Platone grande ammiratore di Socrate
Il giovane Platone si identifica con Socrate. Nei primi due scritti, l'Apologia di Socrate e il Critone, dedicati al racconto della condanna e della prigionia, e nel Fedone, dove vengono narrati gli ultimi momenti del filosofo, emerge la grandezza di Socrate.
Socrate e Platone condividono quattro convinzioni: ritengono che la filosofia sia ricerca del bene e del vero; considerano il dialogo il metodo più adatto alla ricerca della verità; riconoscono alla filosofia il compito di insegnare agli uomini la virtù; ritengono l'insegnamento della filosofia una missione cui dedicare la propria vita.
La polemica di Platone contro i sofisti
Nel Protagora comincia a emergere il pensiero autonomo di Platone. Protagora ritiene di essere insegnante di virtù, ma per Socrate si tratta solo di esperienze personali che non possono essere insegnate. Solo la scienza si può insegnare e la virtù è una sola: avendo infatti per oggetto il bene non può che essere unica.
Nell'Eutidemo Platone critica l'eristica, la tecnica con la quale i sofisti pretendevano di poter confutare qualunque discorso o di sostenere allo stesso modo dottrine opposte. Ma per Socrate essa è solo un gioco di parole e solo la filosofia è il vero sapere.
Nel Gorgia si affronta la retorica, intesa da Gorgia come tecnica della persuasione. Per Socrate invece la retorica non insegna nulla ma è soltanto un abbellimento del discorso, che non serve alla politica intesa come l'arte della giustizia. Per il sofista Callicle poi la giustizia è solo una convenzione degli uomini: male non è causare ingiustizia, se così vogliono i forti. Secondo Socrate, non è male soltanto subire ingiustizia, ma anche commetterla.
Il Cratilo: la conoscenza dei nomi non permette quella della realtà
Sulla questione del linguaggio si contrapponevano all'epoca di Platone due dottrine: la dottrina della convenzionalità del linguaggio (sostenuta dai sofisti: i nomi sono attribuiti alle cose mediante un accordo tra gli uomini); la dottrina della naturalità del linguaggio, (sostenuta da Eraclito: i nomi dipendono dalla natura degli oggetti designati).
Per Platone entrambe queste dottrine sono errate: i nomi sono sì attribuiti dagli uomini, ma in base a una certa somiglianza tra nomi e cose; si spiega così come sia possibile l'imprecisione, e come sia necessario, per giudicare la correttezza di un nome, conoscere non soltanto l'apparenza dell'oggetto, ma la sua vera realtà, quella che Platone chiama idea, intesa come essenza delle cose.
Le forme degenerate di governo nello Stato ideale
Una volta nati i bambini verranno tolti ai loro genitori. Abolite le famiglie, lo Stato sarà una sola, grande famiglia.
Il comunismo dei beni, che interessa solo la classe dei guerrieri e dei governanti, favorirà il bene comune e non la ricchezza del singolo.
Lo Stato platonico è un'utopia, ovvero un modello ideale a cui guardare per l'attuazione dei diversi sistemi di governo.
Vi possono per questo essere alcune degenerazioni, ovvero forme di governo che, secondo Platone, non possono rendere lo Stato giusto.
La prima degenerazione viene definita da Platone timocrazia: si tratta del governo fondato sull'onore, e non sulla sapienza. Segue l'oligarchia, "il governo di pochi": questo tipo di governo è fondato sul censo, cioè sulla ricchezza.
Vi è poi la democrazia, "il governo del popolo". È una degenerazione molto pericolosa in quanto l'eccesso di libertà porta all'anarchia. Infine c'è la tirannide, che sovente nasce proprio dalla crisi della democrazia.
LA CONOSCENZA E L'EDUCAZIONE
La nostra conoscenza è come una linea costituita da due segmenti
Per Platone vi sono due forme di conoscenza che corrispondono ai diversi piani della realtà:
a) La conoscenza sensibile (dóxa, opinione) riguarda le cose sensibili, mutevoli e imperfette e comprende:
1. la congettura (eikasía), che ha per oggetto le impressioni delle cose.
2. la credenza (pístis) che ha come oggetto la percezione chiara delle cose sensibili.
b) La conoscenza razionale o scienza (epistéme) riguarda le idee, immutabili e perfette e comprende:
3. la ragione matematica (diánoia), che ha per oggetto le idee matematiche;
4. l'intelligenza filosofica (nóesis) che ha per oggetto le idee-valori.
L'allegoria della caverna
In una celebre allegoria Platone paragona la condizione umana a quella di alcuni uomini rinchiusi in una caverna sotterranea: questi uomini sono legati in modo da poter guardare solo la parete di fondo della caverna sui cui si proiettano le ombre di statue raffiguranti ogni tipo di oggetti. Per costoro, le ombre sono l'unica realtà esistente. Se però uno di loro riuscisse a liberarsi, potrebbe osservare direttamente le statue e comprendere come gli oggetti prima ritenuti veri non fossero che ombre. Uscito dalla caverna, sarebbe all'inizio abbagliato dal sole, non riuscendo a distinguere con chiarezza gli oggetti, e cercherebbe di osservarli riflessi nelle acque. In seguito potrebbe abituarsi lentamente alla luce, e alla fine vedere il sole stesso e tutte le cose reali.
Se il filosofo desiderasse condividere questa meraviglia con gli altri compagni rimasti al buio, e quindi tornare nella caverna, non riuscirebbe più a identificare le ombre, e gli altri prigionieri lo accuserebbero di essere tornato con «gli occhi guasti»; di conseguenza, sarebbe deriso e i compagni, infastiditi dal suo desiderio di liberarli, lo ucciderebbero.
Il percorso educativo nello Stato ideale
L'attività educativa inizia a sette anni ed è composta da vari momenti, precisamente da tre tipi di apprendimento diversi.
- La disciplina dei sensi, in cui il fanciullo si forma attraverso la ginnastica, lo studio della musica e in parte anche della poesia.
- L'apprendimento delle discipline matematiche.
- L'apprendimento della filosofia: fra i trentacinque e i cinquant'anni, i migliori di coloro che si sono cimentati nelle scienze matematiche passano poi a studiare la filosofia che culmina con la dialettica, cioè la scienza che studia il rapporto tra le idee, e in particolare il rapporto tra il Bene e le idee.
LA SCOPERTA DELLE IDEE
Mondo fisico e mondo intelligibile
Platone, attraverso la dottrina delle idee, distingue il mondo in due piani:
- uno fisico e materiale, che conosciamo attraverso i sensi: il mondo sensibile;
- un altro sovrasensibile, comprensibile solo con la ragione: il mondo intelligibile.
Che cosa sono le idee?
Le idee per Platone sono universali nel senso che sono valide per ogni individuo, in ogni tempo e in ogni luogo. Sono delle entità intellegibili: realtà che avvertiamo solo con la ragione, non con i sensi. Esse sono paradigmi, cioè modelli, del mondo sensibile e della nostra conoscenza.
Le idee si distinguono in due fondamentali tipologie:
1. le idee-valori;
2. le idee-matematiche.
L'idea suprema è l'idea del Bene.
Le idee hanno sede nell'iperuranio
L'iperuranio è luogo metaforico in cui si trovano le idee, totalmente al di là del mondo sensibile.
Le idee entrano in relazione con il mondo fisico attraverso i rapporti di:
- mimèsi, per il quale la cosa imita l'idea;
- metèssi, per il quale la cosa partecipa dell'idea;
- parusìa, per il quale l'idea è presente nella cosa.
LA CONOSCENZA DELLE IDEE
La conoscenza avviene attraverso il processo di anamnèsi
L'anamnèsi è quel processo con cui l'anima arriva a ricordare ciò che ha visto nel mondo delle idee, avendolo vissuto, prima di incarnarsi in un corpo, nell'iperuranio. La conoscenza è per questo innata.
Attraverso il metodo maieutico, l'uomo, correttamente interrogato, scopre che la verità è dentro di lui, nella sua anima; ma questa verità è universale in quanto rimanda al mondo trascendente delle idee.
L'anima è immortale
A sostegno dell'immortalità dell'anima, nel Fedone, Platone elenca tre principali prove:
- prova dei contrari: ogni cosa si genera dal suo contrario; la vita genera la morte e la morte la vita;
- prova della somiglianza: l'anima è simile alle idee, e come le idee è quindi eterna;
- prova della vitalità: l'anima è soffio vitale.
L'AMORE COME DESIDERIO DI BELLEZZA
Il mito di Eros
L'amore, in greco eros, appare nel suo aspetto drammatico di ricerca di qualcosa che manca e di appagamento nel trovarlo: è quindi desiderio di bellezza, intesa come armonia, misura e proporzione.
Eros, sarebbe figlio di Penia (la Povertà) e di Poros (dio dell'Ingegno), cioè della capacità di procurarsi ciò di cui si è mancanti. Essendo figlio di Povertà, Eros è privo di bellezza, ma dal padre ha ereditato l'astuzia per conquistarla. Eros è quindi l'immagine del filosofo, che non possiede la sapienza ma la desidera.
La filosofia è fatta per gli amanti della sapienza, la forma più alta di bellezza.
La scala dell'eros conduce alla sapienza
La scala dell'eros, una volta percorsa, condurrà l'uomo a conoscere la forma più alta di bellezza: si compone di sei gradini.
1. Il primo impulso che dà il via all'ascesi dell'Eros si manifesta nei confronti della bellezza di un corpo.
La scala dell'eros conduce alla sapienza
2. In seguito si scopre la bellezza corporale, e si comprende che la bellezza è uguale in tutti i corpi.
3. Il passo successivo è la scoperta della bellezza dell'anima, cioè dell'amore spirituale.
4. Al di sopra, vi è poi l'amore per la bellezza delle istituzioni e delle leggi, nel senso che si giunge a desiderare di dar vita a valide istituzioni e leggi in quanto sono creazioni dell'anima.
5. Successivamente si rimane ammirati di fronte alla bellezza delle scienze.
6. Infine l'uomo giunge a scoprire la bellezza in sé, la bellezza cioè nel suo essere sapienza, l'amore supremo che è oggetto della filosofia.
L'anima è come una biga trainata da due cavalli
L'anima è come una biga alata trainata da due cavalli, uno bianco e docile, l'altro nero e ribelle. L'auriga cerca di guidare la biga verso il cielo, e di oltrepassarlo per giungere nell'iperuranio dove hanno sede le idee, ma il cavallo ribelle tende sempre a riportare la biga verso il basso, verso le realtà sensibili. In questo modo l'anima non contempla mai in modo compiuto le idee, e quando perde le ali per qualche colpa va a incarnarsi in un corpo.
Analogamente a quanto accade per la conoscenza, la vista della bellezza risveglia nell'anima incarnata il desiderio di elevarsi, ossia l'amore.
LA REPUBBLICA
La tripartizione dell'anima e la virtù della giustizia
Per Platone l'anima è tripartita, divisa cioè in tre parti o funzioni:
- la parte più nobile dell'anima è quella razionale: vivere secondo ragione dà luogo alla virtù della saggezza;
- segue la parte irascibile: sta prevalentemente dalla parte della ragione ma può anche lasciarsi trascinare dai sensi; la difesa del bene, indicato dalla ragione, dà luogo alla virtù del coraggio;
- infine vi è quella concupiscibile (o appetitiva), caratterizzata dal desiderio delle cose percepite dai sensi, la cui virtù è la temperanza, una virtù comune a tutte le parti in quanto consiste nel lasciarsi guidare dalla ragione.
Un individuo è dunque giusto se vive secondo sapienza, coraggio e temperanza; se, in altri termini, ogni parte della sua anima adempie alle sue funzioni, fa ciò che deve fare e lo fa nel modo in cui lo deve fare.
La divisione dell'anima corrisponde alle classi dello Stato
Come l'anima è divisa in tre parti, così lo Stato deve essere diviso in tre classi:
- la prima classe è quella dei governanti (o re filosofi): corrisponde alla parte razionale dell'anima; tipica dei governanti è quindi la virtù della saggezza.
- la seconda classe è quella dei guerrieri (o guardiani): corrisponde alla parte irascibile dell'anima; tipica dei guerrieri è quindi la virtù del coraggio.
- la terza classe è quella dei cittadini comuni (o produttori) dediti a varie attività (artigiani, contadini, mercanti): corrisponde alla parte concupiscibile dell'anima, e quindi ha come virtù la temperanza, anche in questo caso una virtù che condividono con le altri classi, poiché consiste nella concordia tra governati e governanti.
Uno Stato è dunque giusto se ogni cittadino svolge il compito che gli è stato assegnato.
L'abolizione della famiglia e la comunione dei beni
L'abolizione della famiglia permette, secondo Platone, di dar spazio alla "comunanza delle donne". Tutto ciò è finalizzato a migliorare la generazione dei figli: quale criterio ci deve guidare quindi nella scelta della generazione?
Secondo Platone la scelta deve essere riposta nelle mani dello Stato. I migliori si devono accoppiare con i migliori.